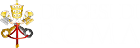Le letture di questa domenica ci aiutano a riflettere sul tema dell’umiltà. Questa virtù, posta al centro dell’insegnamento sapienziale della prima lettura, è ripresa nel Vangelo attraverso due brevi parabole accomunate dal contesto conviviale – il posto da scegliere nella prima e i commensali da invitare nella seconda. Accogliendo l’invito che oggi ci viene dalla liturgia della Parola, riflettiamo brevemente su questa preziosa virtù, l’umiltà, vissuta in pienezza dalla Vergine Santissima.
L’autore del libro del Siracide, nel brano che è stato proclamato, ribadisce un insegnamento cardine dell’Antico Testamento, quello secondo cui Dio volge il suo sguardo sull’umile e sulla persona dal cuore contrito. Oltre che orientare chi ascolta all’umiltà, il brano ci offre la ragione profonda di tale invito: soltanto l’umile trova grazia agli occhi del Signore, Dio rivela i suoi segreti ai miti e dagli umili Egli è glorificato. Di contro, viene evidenziato il rischio grave di chi vive nell’orgoglio e a questa sua condizione spirituale non c’è rimedio, perché l’orgoglio chiude il cuore all’azione di Dio. L’umiltà, invece, è l’atteggiamento esistenziale di chi sa che da Dio riceve tutto; il credente non può non essere umile poiché si riconosce nelle mani del Padre, non si attribuisce nessun merito e non rivendica nessun diritto o privilegio, ma tutto accoglie come dono. Fin dalla prima pagina della Scrittura siamo ci viene mostrato il grande pericolo dell’orgoglio, radice di tutti i mali e padre di tutti i peccati, poiché l’orgoglioso si illude di potersi sostituire a Dio; si fa dio di sé stesso; non serve Dio ma si serve di Dio. Nell’umile, invece, Dio trova spazio – anche lo spazio della povertà e della piccolezza – e agisce. Nell’orgoglioso Dio non può agire perché il soggetto non glielo permette.
Nel Vangelo di oggi, Gesù accetta l’invito a pranzo di un fariseo. In quella casa, rivolge alcune parole prima agli invitati, poi a colui che lo aveva invitato. Ai primi parlerà della scelta dei posti al banchetto e al secondo di chi invitare. Pur essendo “sotto osservazione”, è Gesù stesso che fa attenzione e nota “come” gli invitati sceglievano i primi posti (v. 7). Le sue successive parole nascono da questo sguardo, dunque, dall’osservazione della realtà. E questo rapporto con l’esperienza, con il dato di realtà, spiega il carattere sapienziale delle parole di Gesù. Le sue indicazioni, infatti, sembrano ricalcare il tono di consigli analoghi che troviamo nella letteratura sapienziale dell’Antico Testamento, sempre molto attenta a regolare il comportamento di chi è ammesso a banchetti e a pranzi con persone autorevoli (Pr 23,1; Sir 31,12): “Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire: ‘Sali quassù’, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante” (Pr 25,6-7). Il riferimento ai primi posti contiene una chiara allusione al vizio degli scribi che, come ci ricorda il Vangelo, “ambiscono i primi posti nei banchetti” (Lc 20,46) e dei farisei amano i primi seggi nelle sinagoghe (Lc 11,43; 20,46). E questo vizio di primeggiare, di essere visti occupare posti che dicono autorevolezza e onore, è male che abiti anche la comunità cristiana. Il testo acquista valenza ecclesiologica ricordando a tutti i cristiani che la tavola imbandita del banchetto eucaristico è memoria del Servo del Signore e plasma una chiesa serva, chiede ai credenti di farsi servi gli uni degli altri, di cercare l’ultimo posto, sull’esempio di colui che è venuto non per farsi servire ma per servire. Nel banchetto del Regno, i posti d’onore non spettano ai più visibili, ma a chi si fa piccolo, a chi si mette all’ultimo posto. Le parole di Gesù che Luca colloca durante l’ultima cena hanno esattamente questo tenore: “Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure, io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,26-27). Le parole di Gesù agli invitati, non sono certamente consigli di etichetta conviviale, ma vanno invece colte alla luce del paradosso formulato nel discorso della pianura (Lc 6,20-28) e diventano una critica alla volontà di protagonismo, alla brama di primeggiare, all’ansia di essere ammirati e riveriti. Le parole di Gesù, mostrando un ribaltamento radicale della situazione, per cui chi aveva scelto il primo posto si ritrova all’ultimo e chi si era messo all’ultimo viene fatto avanzare, aprono il testo alla dimensione escatologica, come appare dal v. 11: “Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. Il rovesciamento della sorte intravisto è quello di cui ha già parlato Gesù in Lc 13-28-30 intravedendo la prospettiva escatologica del Regno di Dio: “Vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel Regno di Dio e voi cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e sederanno a mensa nel Regno di Dio. Ed ecco vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi”. Il testo assume anche una valenza etica ponendo in contrasto orgoglio e umiltà. L’umiltà, in questo senso, non è umiliazione ma autenticità, adesione sincera all’“humus” da cui l’uomo è tratto e a cui ritornerà: ci ricorda che siamo creature fragili e ci colloca come tali davanti al Creatore. È in Lui che l’uomo (homo) scopre la vera umanità (humanitas), è in Lui che la creatura comprende il senso del proprio limite e la misura della propria maturità (cf. Ef 4,13).
A questo punto, Gesù rivolge “a colui che l’aveva invitato” (v. 12) parole che, per la mentalità del tempo – e forse anche per la nostra – appaiono sorprendenti e persino scandalose, che gli suggeriscono di invitare a pranzo o a cena non amici e conoscenti ma “poveri, storpi, zoppi, ciechi” (v. 13): questo gesto, infatti, sarebbe totalmente gratuito perché i poveri non possono ricambiare, a differenza dei primi che se ne sentirebbero perfino obbligati. Dunque, anche parlando di un banchetto, Gesù riesce a parlare dell’agire sorprendente di Dio capovolgendo ogni logica umana: nel banchetto del Regno, infatti, sono i poveri ad avere i posti privilegiati e gli ultimi a essere i primi (cf. Lc 14,11). Gesù, dunque, mette in guardia da logiche di do ut des che corrompono le relazioni facendole uscire dalla gratuità e rendendole meri rapporti di potere e d’interesse. Con queste parole Gesù sta pertanto obbedendo alla logica paradossale del Regno di Dio. E rivela che, per l’uomo, questa logica “illogica” diviene fonte di beatitudine: “sarai beato perché non hanno da ricambiarti” (Lc 14,14). La vera beatitudine consiste nella partecipazione alla sorte di Gesù che ha amato unilateralmente gli uomini nel loro peccato e nella loro inimicizia (cf. Rm 5,6 ss.), che non ha cercato ricompense terrene e non ha preteso di essere riamato in cambio del suo amore. La beatitudine, allora, è la gioia di amare in pura gratuità, nella certezza che l’amore basta all’amore e che è ricompensa per chi ama. È la beatitudine di chi è libero dalla paura di perdere qualcosa amando; è la beatitudine di chi spera e attende come unica ricompensa la comunione escatologica con Dio nel Regno (cf. Lc 14,14b); è la beatitudine di chi trova nel dono la propria gioia; è la beatitudine di chi non agisce in vista di un contraccambio, ma donandosi interamente in ciò che vive e che compie.
In Maria contempliamo oltre che la “tutta santa” anche la “tutta umile”, Colei che ha donato a Dio tutto lo spazio della sua vita e del suo cuore. Maria ha vissuto sulla propria carne questa logica rovesciata del Regno, ha accolto l’ultimo posto con gioia, si è fatta serva perché Dio fosse tutto in lei. Lei stessa nel canto del Magnificat ha riconosciuto che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Imitiamo il suo esempio e impariamo da lei a diventare umili, a ricercare gli ultimi posti nella mensa della vita; in questo luogo ricco di grazia deponiamo una volta per tutte il nostro orgoglio e chiediamo che il Signore ci renda miti e piccoli per essere a Lui graditi e per scrutare i segreti del suo cuore.
Amen
31 agosto 2025