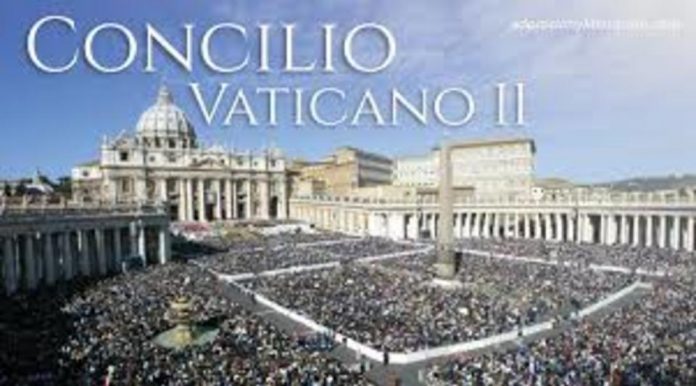IL RIPRISTINO DEL DIACONATO PERMANENTE NELLA CHIESA LOCALE DI ROMA
- Introduzione
1.1. In comunione con tutte le Chiese che sono in Italia e secondo lo spirito e le indicazioni del documento “Comunione e comunità”, pubblicato recentemente dalla CEI, la nostra Chiesa locale sta portando avanti ormai da alcuni anni il suo piano pastorale. Esso mira a fare di Roma una “autentica Chiesa locale, viva ed operante in comunione con il suo Vescovo e con tutte le sue membra, nelle dimensioni che le sono proprie, inserita nel contesto sociale della città”, per realizzarvi una rinnovata presenza di evangelizzazione e di integrale promozione umana.
1.2. In questa prospettiva sono nate e stanno crescendo, sotto l’impulso dello Spirito e con la buona volontà e l’impegno di pastori e fedeli, diverse iniziative che favoriscono nella nostra comunità diocesana una graduale maturazione nella coscienza e nel senso di appartenenza alla Chiesa, come pure una più profonda consapevolezza dei compiti che a ciascuno sono richiesti per vivere la comunione ecclesiale e assumersi più precise responsabilità in ordine alla missione che la Chiesa ha nel mondo per realizzare il progetto divino della salvezza.
1.3. Molteplici e consolanti sono i segni di questo cammino, indubbiamente lento e faticoso ma che si rivela già positivo e ricco di promettenti prospettive. Tra questi basterà ricordarne alcuni: la pubblicazione di diversi sussidi teologico-pastorali da parte del Vicariato per orientare e sostenere questo cammino; la partecipazione sempre più ampia e convinta da parte di sacerdoti e fedeli alle iniziative di formazione promosse a vari livelli e un po’ dappertutto dai Centri e Uffici del Vicariato e dai responsabili dell’azione pastorale; la creazione e la diffusione degli organismi di partecipazione nei quali preti, religiosi e laici, crescono insieme nella comunione e si fanno carico della missione della Chiesa e che hanno sfociato recentemente nella costituzione del Consiglio pastorale diocesano; la promozione sempre più ampia dei ministeri affidati ai laici, siano essi “di fatto” come “di diritto” o istituiti, con l’intento di porre in atto una corresponsabilità differenziata nel servizio che la Chiesa è chiamata a compiere sia al suo interno sia nei confronti del mondo, per portare a tutti l’annuncio del vangelo di Cristo.
1.4. In questo contesto è venuta emergendo con sempre maggiore chiarezza e insistenza, .anche nella nostra Chiesa locale, l’esigenza di affrontare concretamente il problema del ripristino del diaconato permanente, con la conseguente richiesta al Consiglio episcopale di indicazioni e direttive per la realizzazione di un progetto formativo e operativo a questo riguardo.
In realtà già nel 1972-73 sono nate nella nostra diocesi alcune iniziative, anche se di carattere personale e ristretto nell’ambito di istituzioni e gruppi particolari, con lo scopo di dare una prima risposta alla questione. Nonostante i meriti e lo sforzo messo in atto, esse sono andate inevitabilmente incontro a delle difficoltà e hanno suscitato qualche perplessità soprattutto circa l’“ecclesialità” delle proposte e dei mezzi adottati per la realizzazione. per questi motivi nel maggio 1976 il Consiglio episcopale, con un apposito decreto, avocò a se il problema con l’intento di determinare “i modi più opportuni per giungere a detta attuazione, in rapporto alla situazione e alle esigenze della diocesi di Roma”.
La via scelta per una graduale realizzazione del ripristino del diaconato permanente è stata di avviare e favorire intanto una riflessione teologica che consentisse il formarsi di una nuova mentalità circa la ministerialità della Chiesa nel suo insieme. Un particolare riconoscimento va alla specializzazione ecclesiologica della Facoltà di Teologia e all’istituto di scienze religiose della pontificia Università Lateranense, che dall’anno accademico 1981-82 ha previsto uno speciale indirizzo per la formazione teologico-pastorale dei candidati al Diaconato. Contemporaneamente si è cercato di promuovere i ministeri istituiti (lettorato, accolitato e ministero straordinario dell’Eucaristia). Da tutto ciò, come pure dalla messa in atto di una partecipazione più qualificata dei laici alla missione ecclesiale, sarebbe stato più facile giungere ad un chiarimento circa il significato e i compiti del ministero diaconale nella nostra situazione socio-pastorale e sarebbero emerse con più chiarezza le “vocazioni” a questo servizio. Di fatto così sta avvenendo, perciò sembra venuto il momento per dare alcuni orientamenti e norme più precisi per l’attuazione di un piano organico relativo alla promozione del diaconato permanente nella nostra Diocesi.
Siamo sollecitati a ciò anche dal fatto che, dopo un periodo di sperimentazione si è giunti recentemente alla prima ordinazione di un diacono permanente, mentre altre se ne possono già prevedere nel prossimo futuro.
- Alcuni principi e orientamenti di carattere generale
2.1. Non è nostro intento richiamare i dati storici, biblico-teologici, con le conseguenti implicazioni ed esigenze pastorali, riguardanti il diaconato nella Chiesa e il suo ripristino, come grado permanente della gerarchia, sancito dal Concilio Vaticano II. Essi sono stati approfonditi e precisati da importanti documenti del magistero pontificio e della CEI.
Sarà sufficiente, in questa sede, mettere a fuoco alcune questioni e determinare alcuni punti concreti che hanno più diretto riferimento alla situazione della nostra Chiesa locale.
2.2. Sono note la splendida fioritura e lo sviluppo che il diaconato ha avuto a Roma, nei primi secoli, connessi con quelli delle “diaconie”, la cui attività liturgica e soprattutto caritativa è dato conoscere da molti documenti antichi e recenti.
Due sembrano, a giudizio degli studiosi, le circostanze di carattere squisitamente pastorale che, sulla scia dei dati del N.T. e soprattutto degli Atti (cfr. 6, 1-11), determinarono nella nostra città l’istituzione del diaconato e delle diaconie, da mettere in relazione ambedue con l’accrescimento numerico dei credenti e l’estensione territoriale della comunità cristiana.
Innanzitutto l’esigenza di un decentramento dell’attività pastorale, in modo che l’evangelizzazione e il servizio liturgico potessero raggiungere tutti i credenti e quanti man mano giungevano alla fede. il Liber pontificalis, infatti, attesta che già nel sec. III, sotto il pontificato di papa Fabiano, si sentì il bisogno di dividere la città in sette regioni, alle quali fu preposto un diacono; articolazione questa che, qualche tempo dopo, divenne più complessa ed estesa, con la costituzione di diversi “tituli”, affidati alla cura pastorale di un presbitero. Tale suddivisione, tuttavia, non ostacolò l’unità e la comunione con il vescovo di Roma; tanto è vero che fedeli e rappresentanti qualificati delle diverse comunità prendevano parte alla liturgia stazionale che il papa celebrava nelle basiliche e in altre chiese, in particolari occasioni.
A suggerire poi l’istituzione delle diaconie e a valorizzare il ministero del diacono contribuì non poco l’urgenza di dare strutturazione concreta all’assistenza e al servizio di carità nei confronti dei molti poveri e bisognosi della città. Le diaconie, sotto la guida e l’impulso dei diaconi, vennero così a rispondere ad una esigenza e ad un bisogno di primaria importanza della comunità cristiana, divenendo luoghi di incontro e di irradiazione di carità, anche per le generose elargizioni di papi, di chierici e di laici facoltosi particolarmente sensibili al problema. Come i primi sette di cui attestano gli Atti, anche i diaconi romani non esaurirono però la loro attività nel settore caritativo e assistenziale; anch’essi furono preziosi collaboratori dei vescovi, successori degli apostoli. Come afferma la Didascalia apostolorum, essi erano l’occhio del vescovo: vigilavano sulla disciplina; erano il suo orecchio, per fargli giungere le domande e le attese dei fedeli; la sua mano, per fare l’elemosina ai poveri; il suo cuore, per prendersi cura dei malati e dei poveri.
La splendida testimonianza data dal diacono romano Lorenzo ne è una prova eloquente.
2.3. La situazione socio-pastorale della nostra città, oggi, pone problemi analoghi a quelli che s’imposero alla comunità cristiana dei primi secoli, e per di più in dimensioni e forme assai più gravi e complesse. Anche per questi motivi – come diremo appresso – il ripristino del diaconato permanente, sanzionato dal Vaticano ii, costituisce una risposta alle attese di carità e di evangelizzazione che salgono, più o meno consapevolmente, dai credenti e dagli uomini di buona volontà di questa nostra città.
Perché questo fatto non appaia suggerito da preoccupazioni di tipo efficientistico e organizzativo e non risulti una semplice attuazione del dettato conciliare, vorremmo richiamare brevemente le motivazioni profonde che sono alla base della decisione di ripristinare il diaconato permanente nella nostra Chiesa locale. Ciò servirà anche a dissipare le incertezze e le perplessità di alcuni – pastori e fedeli – che non riescono a rendersi conto dell’importanza di questo ministero e ad individuare gli “spazi” concreti del loro servizio.
Due serie di motivi di ordine generale ci hanno sollecitato a prendere seriamente in considerazione il problema della restaurazione del diaconato anche nella nostra comunità ecclesiale. Sono gli stessi che i Vescovi d’Italia hanno espresso nel documento Evangelizzazione e ministeri, pubblicato nel 1977: “il diaconato permanente concorre – affermano i Vescovi italiani -a costituire la Chiesa e a darne un’immagine più completa e rispondente al disegno di Cristo e più in grado, per interna e spirituale potenza, di adeguarsi a una società che ha bisogno di fermentazione evangelica e caritativa. Si tratta dunque di una ragione di ordine teologico e una di carattere pastorale.
2.4. Anzitutto la motivazione ecclesiologica. Con la restaurazione del diaconato permanente lo Spirito Santo offre il dono del ripristino di una struttura sacramentale della Chiesa, la quale – secondo S. Ignazio -”non può essere senza vescovi, presbiteri e diaconi“ e quindi di una abbondante ricchezza di grazie sacramentali per una maggior efficacia nella sua missione di salvezza.
Il diacono, in particolare, ”è segno sacramentale e quindi rappresentante e animatore della vocazione al servizio proprio di Cristo e della Chiesa, sua sposa, chiamata anch’essa a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti. La sua presenza nella Chiesa è destinata a promuovere una più intima comunione dei cristiani tra loro e un loro maggior impegno missionario a sacrificarsi per la salvezza di ogni essere umano.
Il Concilio Vaticano II è venuto incontro ai voti e alle preghiere di voler restaurato il diaconato permanente come ordine intermedio tra i gradi superiori della gerarchia ecclesiastica e il resto del popolo di Dio, perché fosse in qualche modo cerniera tra pastori e fedeli, interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane, animatori del servizio, ossia della diaconia della Chiesa, segno e sacramento dello stesso Cristo Signore, il quale non venne per essere servito ma per servire (Mt. 20, 28).
Il ministero diaconale è, come quello presbiterale, una partecipazione al ministero del Vescovo al quale appartiene in pienezza quella diaconia che è finalizzata alla glorificazione del padre e alla salvezza di tutti gli uomini. Come tale ha un posto e un compito specifici, come pure una propria garanzia sacra- mentale al di là dell’eventuale funzione di supplenza alla scarsità del clero.
2.5. Ragioni di ordine pastorale sollecitano inoltre il servizio diaconale in una Chiesa locale come la nostra che è chiamata ad una evangelizzazione più incisiva e capillare “in una comunità sociale complessa in rapida evoluzione e in costante tensione psicologica” e dove si fanno sempre più evidenti i segni della scristianizzazione, della disgregazione e della povertà soprattutto di valori cristiani.
Durante il cammino che la diocesi ha fatto in questi anni si è sempre più chiaramente avvertita l’esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione mediante una più penetrante presenza pastorale (sul piano familiare, scolastico, di ambienti di lavoro e di categoria, di quartiere e di caseggiato, ecc.). Ebbene il ripristino del diaconato dovrebbe poter contribuire a risolvere problemi tanto delicati e complessi.
Spesso si dice che le parrocchie territoriali di una megalopoli come Roma, per l’eccessivo numero di abitanti che le compongono come pure per la scarsità e l’affaticamento del clero, non sono più in grado di farsi carico della globalità della missione ecclesiale e di dar vita ad una comunità e ad una comunione autentiche ai fini di una presenza evangelizzante e caritativa. Ciò è vero; ma questo fatto non dovrebbe spingerci ad articolare la vita e l’impegno apostolico della comunità più ampia in comunità minori, in cui l’annuncio evangelico, il dialogo della fede, la preghiera comune e il servizio ai fratelli possano assumere una dimensione che sia più a misura d’uomo? Questa conversione di mentalità e di stile esige però animatori e responsabili qualificati che, in comunione con il Vescovo e i presbiteri, si facciano carico di un servizio tanto indispensabile e delicato. Tali dovrebbero essere appunto i diaconi.
D’altra parte si va sempre più affermando nella nostra Chiesa locale il bisogno di una “pastorale degli ambienti” che raggiunga le persone là dove vivono e lavorano, per portare ad esse l’annuncio del vangelo e consentire loro più viva esperienza di Chiesa. Anche in questi luoghi la presenza e l’azione di un diacono scelto e inviato dal Vescovo potrebbe essere un prezioso anello di congiunzione tra chi ha la piena e ultima responsabilità della Chiesa e i gruppi- movimenti di ambiente.
2.6. Da quanto è stato detto fin qui risultano con evidenza la necessità del ministero diaconale e i compiti che possono essere affidati ai diaconi nella nostra situazione.
Essi – com’è noto – esercitano il loro servizio nella triplice direzione dell’evangelizzazione, della liturgia e della carità. Ciò emerge non solo dalla tradizione ecclesiale, che ha il suo riflesso anche nei riti dell’ordinazione diaconale, ma altresì dai documenti più recenti del magistero.
Da una riflessione sulla nostra situazione si evidenziano le ampie e suggestive prospettive d’impegno che si aprono per coloro che, con l’imposizione delle mani e il dono dello Spirito accompagnati dalla preghiera, saranno investiti di questo ministero: Vogliamo delinearne almeno qualcuna tra le più importanti.
Dai futuri diaconi ci attendiamo innanzitutto un servizio qualificato e autorevole della e alla parola di Dio, per una Evangelizzazione più capillare e per la costituzione di piccole comunità di fede, soprattutto tra gli adulti, sia all’interno della parrocchia, come pure nei caseggiati, nelle famiglie, negli ambienti di lavoro e di studio, con particolare attenzione ai lontani e ai più poveri.
Anche il progresso del rinnovamento liturgico, che è dato di constatare nella nostra diocesi, potrà avere un maggior incremento se la preparazione e l’animazione delle celebrazioni, soprattutto dell’Eucaristia domenicale e dei sacramenti, saranno assunte con competenza e in fedele collaborazione con i pastori, da diaconi permanenti, in modo che i credenti, nella liturgia, possano celebrare autenticamente la loro fede in Cristo risorto, manifestarsi come comunità, crescere nella comunione e attingere qui l’energia necessaria per i loro compiti di testimonianza e di servizio.
Finalmente, l’esercizio delle opere di misericordia e lo sviluppo che vanno assumendo, nella nostra diocesi, le iniziative di carità e promozione umana offrono ai diaconi un ulteriore campo di impegno che è proprio della loro vocazione e del loro ministero. Ne dovrà risultare una presenza cristiana più incisiva nelle realtà e nelle istituzioni sociali, in modo che siano evangelicamente fermentate con sapiente competenza e con la libertà di movimento che può più facilmente trovarsi in diaconi appositamente scelti.
2.7. Perché tutto ciò si compia “decorosamente e con ordine” (1 Cor. 14.40) è necessario, tuttavia, che si tenga presente, specialmente in una situazione come la nostra, un dato teologico-pastorale di fondamentale importanza, e precisamente il legame necessario e strettissimo di comunione e di dipendenza che deve sempre esistere tra i diaconi e il Vescovo “supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale nella comunità diocesana”.
Nell’esercizio del loro ministero i diaconi dipendono direttamente dal Vescovo, non solo in forza dell’ordinazione sacramentale loro conferita ma anche per l’incardinazione nella Chiesa particolare. Questo legame che è – come dicevamo – di carattere teologico-sacramentale ma anche pastorale-giuridico, comporta una serie di conseguenze che bisogna tenere ben presenti.
Al Vescovo competono la responsabilità e l’autorità circa il riconoscimento della vocazione dei candidati al ministero, la loro formazione, l’ammissione all’Ordine e l’esercizio della diaconia. È dovere dei diaconi, da parte loro, agire sempre in perfetta comunione con il Vescovo e il suo presbiterio; essi dovranno testimoniare perciò una sincera disponibilità alla collaborazione apostolica, ad un servizio organicamente inserito in una pastorale d’insieme e agire quindi alle dipendenze e secondo le indicazioni e direttive di coloro che lo Spirito santo ha posto a reggere la Chiesa di Dio (cfr. Atti 20, 28).
Per tutti questi motivi anche se le vocazioni al diaconato nasceranno -come è naturale – all’interno di una comunità parrocchiale o di un determinato gruppo o movimento ecclesiale, bisogna ricordare che il discernimento di esse, la cura per la loro formazione l’ammissione all’Ordine e soprattutto l’esercizio del ministero (sia per ciò che concerne il campo concreto di lavoro come pure i luoghi) restano legati al giudizio e alla decisione del Vescovo. Egli disporrà dei diaconi della Chiesa locale secondo le esigenze e i bisogni della comunità diocesana tenendo conto, per quanto è possibile, anche delle aspirazioni e inclinazioni personali, della loro preparazione e delle loro possibilità. Si eviterà così il rischio sempre ricorrente di fare delle “chiesuole” anziché la Chiesa una santa cattolica e apostolica, convocata dall’amore del padre, scaturita dal mistero pasquale di Cristo, animata dallo Spirito e da esso unificata nella comunione e nel ministero.
2.8. La decisione del Vescovo di ripristinare il diaconato nella sua Chiesa locale non è però sufficiente ai fini di una effettiva ed efficace valorizzazione del ministero affidato ai diaconi.
È assolutamente indispensabile anzitutto che maturi nella comunità ecclesiale una vera coscienza “diaconale” o ministeriale, sulla base delle suggestioni e degli stimoli contenuti nel noto e già ricordato documento della C.E.i. Evangelizzazione e ministeri. E, con essa, un nuovo stile pastorale, ispirato al discernimento e alla valorizzazione dei carismi dei singoli, alla comunione, partecipazione e corresponsabilità, al decentramento dell’attività pastorale, alle esigenze della missionarietà.
Se le nostre comunità non compiono questo cammino è impossibile che maturino vere vocazioni alla diaconia; queste tutt’al più si manifesteranno come fatto puramente individuale, staccate dal loro naturale contesto comunitario e perciò non pienamente autentiche. La diaconia infatti nasce dalla comunione ed è finalizzata ad essa. Il diacono non è soltanto segno sacramentale di Cristo, Servo del padre e degli uomini, ma testimone di una Chiesa che è al servizio del mondo. Il suo ministero perciò nasce in un contesto comunitario e deve avere una espressione comunitaria. per questo la parte che la comunità ha nella segnalazione dei candidati diventa molto importante.
- Norme pratiche
3.1. Poiché, come abbiamo appena accennato, esiste un intimo rapporto tra il diacono e la Chiesa, che egli è chiamato ad animare e rappresentare sotto l’aspetto del servizio, il criterio da adottare nella scelta dei candidati non è quello della semplice accoglienza di un’aspirazione personale e tanto meno del riconoscimento di qualche merito, bensì quello più ecclesiale che valorizza e suggella con il segno sacramentale un servizio che già si compie con impegno e con frutto nella comunità (parrocchiale, infraparrochiale o di altro genere) e da essa riconosciuto e apprezzato.
Questo perciò dovrà essere testimoniato non solo dal parroco e dal presbitero della comunità parrocchiale in cui il candidato è inserito, ovvero dal sacerdote preposto al gruppo o movimento ecclesiale al quale appartiene, ma anche dalla stessa comunità in cui vive e opera: ciò potrà avvenire concretamente attraverso una lettera di presentazione al Vescovo.
3.2. Per essere presentato si richiede che il candidato già eserciti di fatto un servizio nell’ambito della comunità. In tal modo la grazia sacramentale verrà a corroborare una realtà in atto, verificabile con criteri oggettivi.
Per poter intraprendere il cammino di preparazione al diaconato l’aspirante dovrà avere alcune qualità fondamentali: sia una persona animata da notevole spirito di fede e di preghiera, da un grande amore alla Chiesa e da una particolare disponibilità al servizio. Egli dovrà distinguersi per quelle virtù umane che sono richieste dalla diaconia, come la capacità al dialogo e alla collaborazione, l’apertura agli altri, un certo grado di maturità umana e di prudenza e un forte senso morale e di responsabilità. Saranno accolti come candidati persone di ogni classe sociale e professione civile, purché ritenuta dall’ordinario compatibile con il ministero diaconale. per il fatto che il diacono è chiamato ad essere un uomo di comunione sarà opportuno che lasci ai laici gli impegni di una politica attiva considerata oggi come un’attività troppo di parte.
L’Ordinario diocesano, direttamente o attraverso il Delegato diocesano del diaconato permanente, si riserva comunque la valutazione e il giudizio definitivo per l’ammissione del candidato al cammino di preparazione all’ordinazione.
3.3. Secondo quanto stabilito dal m.p. Sacrum diaconatus ordinem di Paolo VI e dai documenti applicativi della CEI, l’età canonica minima per l’ammissione al diaconato è di 25 anni per i celibi e di 35 anni per i coniugati. Nella nostra diocesi riteniamo opportuno stabilire come età massima per intraprendere il cammino di formazione al diaconato il 60.mo anno di età.
I diaconi sposati dovranno essere nel matrimonio da qualche anno, il che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare. per essi è richiesto anche l’assenso della moglie e una piena adesione nel lavoro pastorale. A tale scopo le mogli sono invitate a prendere parte agli incontri spirituali, in modo da poter comprendere la vocazione del marito e collaborare alla sua missione. Il con- senso della sposa sarà richiesto dall’Ordinario non solo nell’ordinazione, ma anche al momento dell’ammissione all’Ordine.
I candidati celibi prima dell’ordinazione s’impegnano davanti a Dio a conservare il celibato che, “assunto in tal modo, costituisce un impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduto la moglie, secondo la disciplina tradizionale della Chiesa, sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio”.
Tutti i candidati al diaconato, finalmente, prima di ricevere l’ordinazione, dovranno consegnare all’Ordinario una dichiarazione sottoscritta nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l’ordine sacro.
3.4. Per ciò che riguarda la formazione dei candidati al ministero, tenuto presente che essa deve essere globale e quindi abbracciare gli aspetti dottrinali, spirituali e pastorali, stabiliamo quanto segue:
– Per la formazione dottrinale: essa dovrà essere garantita attraverso la partecipazione ai Corsi sistematici di teologia esistenti nella diocesi, con particolare attenzione all’apposito Corso previsto all’interno dell’Istituto di Scienze religiose della pontificia Università Lateranense e promosso dai Centri pastorali del Vicariato.
La durata del periodo di preparazione sarà normalmente di quattro anni. per coloro che hanno già frequentato un corso teologico si studierà caso per caso la possibilità di un completamento del piano restando sempre che l’itinerario formativo, nella sua globalità, richiede degli studi attraverso la partecipazione a Corsi integrativi, salvo uno spazio di tempo adeguato e che non può essere con leggerezza ridotto.
A questo proposito sentiamo il dovere di affermare che la partecipazione ai Corsi non dà di per se alcun diritto all’ordinazione. L’ammissione ad essa, infatti, richiede un discernimento e un giudizio che appartiene al Vescovo e deve tenere conto di tutto l’insieme delle condizioni richieste.
– Per la formazione pastorale: l’esercizio di un servizio particolare alla comunità, che i candidati dovrebbero già compiere, non può ritenersi sufficiente per una preparazione in un campo tanto delicato e complesso. Sarà pertanto necessario che i futuri diaconi siano aiutati a conoscere la realtà globale della nostra Chiesa locale, come pure le esigenze che in essa ci sono, in modo da essere preparati a dare il loro specifico contributo alla soluzione dei problemi emergenti, con una particolare attenzione all’impegno di evangelizzazione che nella situazione attuale della nostra diocesi si rivela indubbiamente prioritario.
L’attività pastorale del diacono dovrà altresì svolgersi in piena comunione con il Vescovo, in un atteggiamento di collaborazione con i presbiteri e i laici e in assoluta fedeltà agli obiettivi del piano pastorale diocesano e secondo le indicazioni in esso proposte.
Potrà rivelarsi molto utile uno scambio periodico tra gli aspiranti e i diaconi, non solo per mettere in comune esperienze e difficoltà e ricercare insieme le vie migliori di un apostolato fruttuoso, ma anche per crescere nella reciproca conoscenza e nell’amicizia fraterna e stimolarsi al fervore e all’impegno.
Per un migliore inserimento nella vita pastorale i diaconi saranno membri di diritto dei rispettivi consigli parrocchiali, mentre una loro rappresentanza sarà assicurata nel Consiglio pastorale diocesano.
– La formazione spirituale, che si alimenterà alle sorgenti della parola di Dio e della Liturgia, sarà indirizzata a creare un vivo spirito di servizio, vissuto nel- l’umiltà e nella gioia e in profonda comunione con Cristo e con i fratelli, e in particolare con i pastori.
Per favorire e sostenere questa formazione sono previsti incontri periodici di carattere spirituale, ai quali è opportuno che partecipino anche le mogli e le famiglie dei candidati e dei diaconi sposati. Tutti poi dovranno avere contatti personali frequenti con il delegato diocesano e con il Vescovo. Un momento fondamentale per la vita spirituale sarà costituito dagli esercizi spirituali che si terranno prima dell’ordinazione e possibilmente ogni anno.
Gli aspiranti al ministero diaconale saranno avviati alla preghiera, in particolare a celebrare Lodi e Vespro, possibilmente insieme con i sacerdoti e laici della loro comunità. partecipino all’Eucaristia per quanto è possibile ogni giorno, si accostino con frequenza al sacramento della penitenza e alimentino una sincera devozione alla Vergine Maria.
3.5. La formazione dei diaconi non si esaurisce nel periodo che precede l’ordinazione. Essa sarà assicurata anche dopo, attraverso iniziative adeguate. I diaconi perciò prenderanno parte volentieri agli incontri che saranno organizzati per loro, sia a quelli di carattere spirituale che a quelli di carattere teologico-pastorale e nei quali saranno affrontati e trattati problemi relativi al- la loro vita e alloro ministero in rapporto soprattutto a questioni o avvenimenti che eventualmente emergessero nella vita della diocesi.
Faranno in modo, in particolare, di partecipare agli incontri ecclesiali promossi annualmente nella diocesi, come pure ai Convegni nazionali sui problemi del diaconato.
3.6. È compito dei Vescovi curare la formazione dei candidati promuovendo apposite istituzioni. Finora gli incontri spirituali e formativi si sono svolti presso il Seminario romano maggiore. È nostro intento destinare una sede specifica a questo scopo, nella quale saranno promosse anche altre iniziative per la formazione dei candidati ai ministeri istituiti nella nostra diocesi.
Tale sede è costituita presso la chiesa di S. Teodoro al palatino (v. S. Teodoro n. 7), che è una delle più antiche “diaconie” della Chiesa romana. La responsabilità di questo Centro viene affidata al p. Luca Brandolini c.m., Responsabile del Centro pastorale per il culto e la santificazione presso il Vicariato di Roma.
3.7. Il coordinamento poi delle iniziative per la formazione dei diaconi è affidato al Delegato diocesano per il diaconato permanente, da noi già nominato il1 ° aprile 1980 nella persona di Mons. Francesco peracchi. Egli, soprattutto per ciò che attiene le iniziative della formazione teologico-pastorale, si avvarrà della collaborazione del Responsabile del Centro per il diaconato e i ministeri di S. Teodoro e degli altri organismi diocesani a ciò interessati.
3.8. Per ciò che concerne il sostentamento dei diaconi permanenti nella nostra diocesi, stabiliamo che essi vivano normalmente del loro lavoro professionale. per coloro che eventualmente fossero invitati a lasciare o a limitare la loro attività professionale, per dedicarsi a tempo pieno al ministero, si provvederà da parte della diocesi o delle comunità nelle quali prestano servizio, sulla base di accordi che saranno presi caso per caso.
Conclusione
La nostra decisione di ripristinare il diaconato nella Chiesa di Roma – maturata nella comunione del Consiglio Episcopale Diocesano -, come già è avvenuto in molte altre Chiese sorelle d’Italia e del mondo, vuole rispondere alle stesse esigenze di comunione e di missione che spinsero gli apostoli a imporre le mani e invocare lo Spirito sui primi sette diaconi della Chiesa (cfr. Atti 6, 1 ss.).
Come loro anche noi, Vescovi responsabili col Pastore della Diocesi, il Papa Giovanni Paolo II, affidiamo ora questa decisione alla preghiera della comunità cristiana. Maria, la “serva del Signore” (cfr. Lc. 1,38) ci ottenga da lui la grazia di un rinnovamento della nostra Chiesa nello spirito di comunione e di servizio, in modo che molte vocazioni al ministero possano manifestarsi e affermarsi tra noi, affinché la parola di Dio si diffonda e si moltiplichi grandemente il numero dei credenti (cfr. Atti 6, 7).
Roma, 1° novembre 1982
Festa di Tutti i Santi
Ugo Card. Poletti
Vicario Generale di Sua Santità