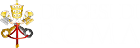Di seguito il testo dell’intervista concessa a Città Nuova dal cardinale vicario Baldo Reina
Il cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, ha ricoperto, per quasi un decennio, il ruolo di rettore del Seminario Maggiore di Agrigento. Nell’intervista Sua Eminenza ricorda gli anni trascorsi nella diocesi, affrontando il tema del sacerdozio, la responsabilità nel percorso di formazione dei seminaristi e dei loro aspetti spirituali e umani. Riflessioni, queste, approfondite in occasione della presentazione del libro di Chiara D’Urbano Vocazioni Felici (San Paolo 2025), tenutasi lo scorso aprile.
Nel corso della sua lunga esperienza di formatore dei futuri sacerdoti, quali sono stati gli obiettivi prioritari fissati e le difficoltà eventualmente incontrate?
Nell’espletamento dell’incarico di formatore, anche alla luce della mia esperienza di seminarista, mi sono subito reso conto che i tempi erano maturi per un cambio di paradigma: l’esperienza seminariale dei ragazzi non poteva essere volta soltanto a verificare la loro effettiva vocazione, ma doveva essere utile anche a incentivare il loro confronto con il mondo esterno. L’obiettivo primario è stato il tentativo di conciliare la concentrazione e il raccoglimento per il discernimento con l’apertura al mondo esterno che nel frattempo assiste a cambiamenti inediti. L’istituzione del Seminario segue lo stesso schema fin dal Concilio di Trento, avviare dunque dei cambiamenti non è stato facile. È stato particolarmente d’aiuto far seguire ai ragazzi esperienze pastorali in contesti ambientali diversi. Quando i ragazzi si aprivano a realtà esterne di missione e di sofferenza, come il carcere, i quartieri disagiati e le diverse forme di povertà, tornavano in Seminario diversi: diversa la qualità della preghiera, diverso lo studio, diverse le relazioni tra loro.
Quanto hanno influito nel suo percorso sacerdotale le origini siciliane? La conoscenza della cultura, delle tradizioni della terra in cui è nato e si è formato hanno favorito l’adempimento dei numerosi incarichi pastorali e apostolici svolti nella Diocesi agrigentina?
C’è sempre un’osmosi, un condizionamento, tra il contesto e le persone che lo vivono. Io ho attinto molto dal contesto di origine. Provengo da un paesino dell’entroterra agrigentino, San Giovanni Gemini. La mia è una famiglia di umili origini, mio papà lavorava in campagna, mamma era casalinga. Entrambi mi hanno fornito da subito l’amore all’essenziale, alla semplicità e alla dimensione del sacrificio. La mia famiglia è stata il mio primo Seminario. Anche il sentimento religioso era ed è particolarmente forte in Sicilia. Fin da piccolo mi sono nutrito di una spiritualità ancora molto sana. Ma ben sappiamo che la Sicilia vive anche un’altra triste realtà data dalla contaminazione di logiche malavitose che condizionano negativamente tutto il contesto territoriale e ti segnano, anche se non ti appartengono. Come formatore, dunque, ho cercato di aiutare i ragazzi a dialogare proprio con il territorio di appartenenza, a far maturare una coscienza critica nei confronti dello stesso, poiché il cambiamento è frutto di conoscenza e consapevolezza. Ho sollecitato i miei seminaristi a considerare l’incarnazione il principio cardine della fede cristiana. Dio si fa carne ed entra pienamente nella storia dell’umanità ed il presbitero è chiamato a rivivere nella sua persona e nel suo ministero il principio dell’incarnazione. Un presbitero che non diventa carne di una comunità, condividendone le gioie e i dolori, ha poco da dire.
Quanto le pregresse esperienze vissute incidono ora nello svolgimento di ministeri di maggiore complessità e responsabilità?
Aver lavorato tanti anni in Seminario mi aiuta nello svolgimento del mio attuale ministero, soprattutto nel rapporto con i sacerdoti. Quando parlo con un sacerdote ascolto attentamente il racconto della sua storia, non solo gli incarichi a lui assegnati, ma anche della sua formazione in Seminario. Inoltre, come già accaduto in Sicilia, sin dal mio arrivo a Roma, come Vescovo ausiliare, ho cercato di conoscere il territorio che mi era stato affidato. Per “territorio” intendo il termine nella sua accezione più ampia, perché non è la parrocchia che deve abbracciare il territorio ma è il territorio che al proprio interno ha anche la parrocchia. Quest’ultima è una parte che compone il territorio e deve necessariamente averne cognizione non per risolvere i problemi di tutti, ma per donare a ognuno una risposta di Vangelo.
Quali sono le dinamiche che caratterizzano la vita comunitaria all’interno di un Seminario per conciliare le opportunità di crescita spirituale e intellettuale di ciascuno con la promozione del senso di condivisione e fratellanza?
Chi entra in Seminario ha già elaborato un suo discernimento vocazionale e desidera diventare sacerdote. Una volta chiesi ai seminaristi di enunciare chi fosse il sacerdote. Diverse furono le riflessioni proposte: «È l’uomo di Dio; è l’uomo della gente; è l’uomo che insegna la verità; è l’uomo di carità». Il denominatore comune di tutte le giuste risposte date era solo uno: «È l’uomo». Spesso dimentichiamo che il sacerdote è in primo luogo un uomo ed è pertanto fondamentale prendersi cura della persona che ha maturato una scelta così importante. Importante è capire lo stato d’animo dei seminaristi e la loro dimensione affettiva e relazionale e solo successivamente valutare l’andamento degli studi e del resto. Prima di accogliere un ragazzo in Seminario parlavo con la sua famiglia per verificare l’eventuale esistenza di traumi. Come potrebbe un ragazzo, diventato sacerdote, farsi chiamare “padre” se con il suo di padre ha vissuto un rapporto conflittuale che non ha saputo o potuto gestire? Occorre valorizzare le scienze umane, la psicoterapia, le dinamiche di gruppo o i colloqui personali per analizzare con la dovuta delicatezza e attenzione le singole dimensioni umane. Questo obiettivo è stato certamente faticoso ma gratificante, poiché un giovane non consegna la propria e più intima sfera emotiva senza un rapporto di fiducia.
Secondo la sua esperienza, la vocazione è il frutto di una chiamata divina o è il risultato di un ambizioso cammino di studio e ricerca interiore? E quanto pesa il contributo personale di un Rettore in tale scelta?
A volte c’è la tentazione dell’ambizione personale che fa intravedere nella vita sacerdotale la possibilità di una vita comoda. Nella realtà il cammino sacerdotale è tutt’altro che agiato. Il seminarista va immerso nella realtà, perché la vita del sacerdote è totalmente donata al prossimo senza concessioni alle ambizioni personali. Personalmente non sento di essere stato un modello per i seminaristi, ma ho sempre cercato di testimoniare ai ragazzi una via di autenticità. L’uomo/sacerdote autentico sa riconoscere i propri limiti: chiede perdono al Signore, al prossimo, alla Chiesa. Ho insegnato ai seminaristi a non farsi un’idea utopistica del sacerdote, dell’uomo immacolato esente da limiti e tentazioni solo perché prega. Egli è semplicemente un uomo comune che ha ricevuto una vocazione altissima. Ed è proprio dentro questo confronto, tra la povertà della propria natura e la ricchezza di Dio, che si scopre il fascino del Ministero. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi scrive «quando sono debole è allora che sono forte». Il mio obiettivo primario verso i seminaristi non era farli diventare sacerdoti ma renderli “uomini felici”.
Ampliando la prospettiva, la storia dell’umanità non ha mai sperimentato una così veloce evoluzione dello sviluppo tecnologico, dei processi di globalizzazione, degli assetti geo-politici e della percezione di valori. In tale realtà, spesso destabilizzante, quale sfida attende la Chiesa Cattolica e la missione sacerdotale?
La mia visione della sfida che attende la Chiesa e la missione sacerdotale è quella di un ex formatore, perché chi è stato formatore non smette mai di esserlo. Oggi la sfida è conoscere le sfide del mondo. La Chiesa non deve contrapporsi alle altre realtà: la politica, la globalizzazione, la tecnologia, i social… La Chiesa deve analizzare tali realtà e attivarsi per acquisire il buono che esiste in esse. La Chiesa deve inoltre sollecitare le coscienze, perché è nella coscienza che avviene il discernimento e la comprensione di ciò che è bene e di ciò che non lo è. Occorre tentare una forma di conciliazione con le realtà che oggi affollano il nostro mondo. La missione che attende dunque la Chiesa rispetto ai sacerdoti è renderli consapevoli di queste sfide e fare in mondo che dentro queste sfide si entri con l’unico tesoro che abbiamo, che è il Vangelo.
26 settembre 2025