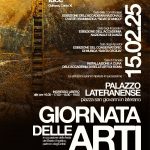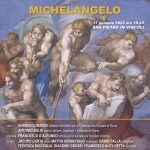Dal titanico progetto per il monumento funebre di Giulio II traspare tutta la tragica esperienza del Buonarroti, l’artista esule, in perenne conflitto con sé stesso, macerato da un sentimento di profonda diffidenza nei confronti del genere umano, della famiglia e dei suoi stessi collaboratori. Unica eccezione, la nobile amica e confidente, Vittoria Colonna, legata al circolo degli âSpiritualiâ, un sodalizio di menti illuminate, come lâumanista Marcantonio Flaminio, il cardinale inglese Reginald Pole e il predicatore cappuccino Bernardino Tommassini (detto Bernardino Ochino), dei quali lâanziano Michelangelo condivise gli ideali riformistici, frutto di una nuova coscienza individuale maturata ai limiti dellâortodossia cattolica.
Lâiconografia del complesso apparato sepolcrale sarebbe il riflesso di questâesperienza religiosa elaborata su un testo fondamentale, il Beneficio di Christo (il Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Christo crocefisso verso i cristiani, pubblicato nel 1543), nel quale è scritto che la salvezza dell’uomo, fondata sul sacrificio in Croce del Figlio di Dio – qui adombrato nellâimmagine di Mosè, depositario della Legge divina – si raggiunge per mezzo delle opere di Carità e, soprattutto, con la propria Fede in Cristo. Già il Vasari aveva identificato nella statua a destra âLia, figliuola di Laban, per la Vita attiva, con uno specchio in manoâ, unâimmagine non esattamente corrispondente al suo autentico significato. Al posto della ghirlanda di fiori, associata dal Condivi al magistero di Dante âche nel suo Purgatorio finge aver trovata la contessa Matilda, qual egli piglia per la Vita attiva, in un prato di fioriâ e allo specchio simboleggiante âle virtù che ornano la vita nostra in vita e dopo la morte la fanno gloriosaâ, è ben visibile un serto di alloro sempreverde e, sulla mano destra, il fuoco di una lucerna alimentata – secondo lâantica sapienza medievale – dai fluenti capelli che vi ardono sopra come fiamme. A sinistra, la corrispondenza di âRachel, sua sorella, per la Vita contemplativa, con le mani giunte, con un ginocchio piegato, e col volto par che stia elevata in spiritoâ alluderebbe, piuttosto, alla Fede che si nutre del suo stesso sguardo rivolto al Ciclo. La torsione del patriarca biblico, come dimostrano alcune sostanziali modifiche abilmente dissimulate nel marmo, sarebbe il risultato di un ultimo intervento sullâopera già quasi ultimata, per compiersi nel sublime volto illuminato dal raggio divino che si fa luce terrena penetrando dalla finestra – oggi murata – un tempo esistente nella parete del transetto. Lâapertura in alto è un ulteriore espediente attuato per esaltare lâoriginaria funzione del grandioso sepolcro papale, concepito come corpo architettonico isolato, in relazione al definitivo progetto elaborato per San Pietro in Vincoli dal Buonarroti, il quale âsopra il Profeta e la Sibilla, nel vano della nicchia, vi fece per ciascuna una finestra per comodità di que’ frati che ufiziano quella chiesa, avendovi fatto il coro dietro, che servono, dicendo il divino ufizio, a mandare le voci in chiesa et a vedere celebrareâ (Vasari).
(Alfredo Marchionne Gunter su Roma Sacra. Guida alle chiese della Città Eterna â Giugno 2005, Anno XI, N. 31)
Per approfondimenti:
IL MOSE’ DI MICHELANGELO E LA “TRAGEDIA DELLA SEPOLTURA”: LA TOMBA DI GIULIO II E LE SUE VICENDE, DALLA BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO A SAN PIETRO IN VINCOLI di Andrea Lonardo
http://www.gliscritti.it/approf/2008/conferenze/lonardo020608.htm
IL MOSE’ DI MICHELANGELO HA LE CORNA. PERCHE’? di Andrea Lonardo
http://www.gliscritti.it/blog/entry/4411