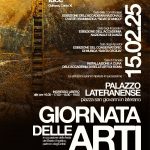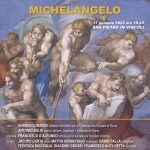Ventiquattro è il numero del cinema o, almeno, lo è stato per lungo tempo. Corrisponde alla quantità di fotogrammi che si susseguono in un secondo, stabilendo unâunità di misura che le tecniche di ripresa digitale hanno fatalmente messo in discussione. Dagli analogici 24fps (è lâacronimo di âfotogrammi per secondoâ, appunto) si è passati presto ai 30fps e, oggi come oggi, lo standard dei 60fps inizia a essere considerato più che raccomandabile. A proposito: in francese – che del cinema resta pur sempre la lingua madre â âdigitaleâ si dice numérique, e con questo torniamo al punto. Al fatto, cioè, che il rapporto fra cinema e matematica si pone anzitutto in termini di tecnologie e di linguaggi, estendendosi poi allâambito dei contenuti narrativi. Volendo giocare ancora un po’ con le parole, si potrebbe insistere sulla parentela strettissima che corre fra âcontareâ e âraccontareâ, in una dimensione che vale per tutte le arti (la metrica in poesia, le battute in musica eccetera) e che assume nel cinema un significato ancora più impegnativo.
Bene, ma allora come mai sul grande e sul piccolo schermo la matematica incute tanta soggezione? Per via della crisi finanziaria che ci ha portato a diffidare degli algoritmi preposti agli investimenti, forse? La risposta è troppo facile, e non solo perché anche in questo caso il cinema ha giocato dâanticipo. Recuperate, se vi capita, una curiosa produzione australiana diretta da Robert Connolly nel 2001, The Bank, e vedrete come già allora âil nemico pubblico numero 1â – così il sottotitolo italiano – fosse identificato proprio nellâeconomia senz’anima delle cifre che si alimentano da sole.
Spunto ripreso – più di recente e con maggior efficacia spettacolare – da Money Monster di Jodie Foster (2016), dove a scagionare la matematica dalle imputazioni che le vengono mosse provvedono due divi conclamati come George Clooney e Julia Roberts: i numeri, di per sé, non avrebbero colpe, a meritare la condanna sono semmai i faccendieri che li manipolano a piacimento per derubare gli ignari risparmiatori.
Che della matematica, e dei matematici, ci si possa perfino fidare lo sosteneva già una serie televisiva di discreto successo, Numb3rs, andata in onda tra il 2005 e il 2010 e incentrata sulle straordinarie doti di calcolo del giovane Charlie Eppes (lâattore David Krumholtz), al quale il fratello Don, agente del- lâFbi, si rivolge abitualmente per avere consulenza sui casi più complicati. Riconsiderata in prospettiva matematica, infatti, la realtà riesce a rivelare aspetti inattesi, a volte addirittura sconvolgenti. Basti pensare alla saga cinematografica di Matrix dei fratelli Wachowski (tre film fra il 1999 e il 2003), ambientata in un futuro sinistramente simile al nostro presente. O, meglio, al presente di quasi ventâanni fa. La realtà è stata ormai soppiantata da una simulazione gestita dalle macchine e il solo in grado di decodificare le stringhe di comando di cui si serve la famigerata Matrice è lâeletto Neo, lâeroe messianico impersonato da Keanu Reeves.
Siamo di nuovo precipitati nel lato oscuro della matematica, dal quale molti matematici raccontati dal cinema sembrano contagiati. Il caso più noto è probabilmente quello di A Beautiful Mind di Ron Howard (2002), biografia molto romanzata del Nobel John Nash, che per l’occasione ha le fattezze dell’attore Russell Crowe. Come il Neo di Matrix, anche Nash intravede strutture matematiche dappertutto. à un dono che gli permette, tra l’altro, di mettere a punto la celebre âteoria dei giochiâ, ma anche una condanna, che lo precipita in una condizione patologica molto prossima alla schizofrenia.
Un altro famoso supermatematico con superproblemi è il protagonista di Will Hunting. Genio ribelle, diretto nel 1997 da Gas Van Sant con Matt Damon nel ruolo principale e il compianto Robin Williams in quello dello psicologo incaricato di venirgli in soccorso. Di origini umilissime, Will è in effetti una specie di genio leonardesco, a suo agio in qualsiasi disciplina. Il suo forte resta comunque la matematica, come dimostra risolvendo con disinvoltura la complessa equazione che uno dei professori del College ha lasciato sulla lavagna in sfida agli studenti. Peccato che Will non sia neppure iscritto al corso e che passi di lì per caso, seguendo la sua routine di addetto alle pulizie.
La galleria dei matematici eccentrici è davvero molto amata dai cineasti. Nel 2005 in Proof. La prova il regista John Madden si ispira allâomonimo dramma di David Auburn per descrivere i tormenti di Robert (interpretato da Anthony Hopkins), altra mente tanto sopraffina quanto disturbata. Il genio questa volta ha una figlia, Catherine (Gwyneth Paltrow), a sua volta abilissima con i calcoli. Tutto sta a capire se anche la follia debba essere considerata un tratto ereditario. E poi – anzi, prima ancora â câè Raymond, ossia Rain Man. Lâuomo della pioggia. Anno 1988, Barry Levinson alla regia e un Dustin Hoffman da premio Oscar nei panni del fratello autistico del quale il rampante Charlie (Tom Cruise) ha finora ignorato resistenza. Il loro sarà un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, con una tappa a Las Vegas durante la quale lâintroverso Raymond da dimostrazione della sua abilità , nella previsione statistica, azzeccando una sequenza sbalorditiva di numeri vincenti. Si tratta di una situazione analoga a quella rievocata in 21 di Robert Luketic (2008), tratto dal reportage che lo scrittore Ben Mezrich ha dedicato al caso – autentico – di un gruppo di giovani matematici capaci di sbancare qualsiasi tavolo di blackjack. Tra i pochissimi film che riescono ad andare al di là di questo pur affascinante cliché del genio irregolare, andrà segnalato almeno il magnifico esordio di Mario Martone, quel Morte di un matematico napoletano (1992) che permise a Carlo Cecchi di dare volto alla tragedia di Renato Caccioppoli, suicida nel 1959 all’età di cinquantacinque anni.
Non solo i matematici, ma anche i numeri possono essere maledetti. Ne sa qualcosa il Jim Carrey di Number 23, un thriller del 2007 che porta la firma dello specialista Joel Schumaker. A scatenare l’ossessione è, nella fattispecie, un libro misterioso, che pretende di svelare gli arcani del numero 23 e che, neanche a farlo apposta, manca proprio del fatidico capitolo ventitreesimo. Quanto ad alleanza perversa tra simbolo già matematica e letteratura, però, nessun film è finora riuscito a eguagliare il corrusco Seven di David Fincher (1995), dove la strana coppia di detective composta da Morgan Freeman e Brad Pitt cerca di sventare il piano ordito dal diabolico serial killer Kevin Spacey. Il sette del titolo – che in origine si presentava come Se7en – è un richiamo, trasparente e minatorio insieme, allâelenco dei peccati capitali.
Fortuna che, ogni tanto, con i numeri il cinema riesce anche a scherzare. Sette spose per sette fratelli, per esempio, è il titolo di un musical diretto da Stanley Donen nel lontano 1954. La trama? In un West da operetta i rudi fratelli Pontipee, boscaioli e attaccabrighe assai danzerini, si decidono finalmente a prendere moglie. Dâaccordo, il rimando al mito romano del ratto delle Sabine è un ricordo molto lontano, ma a colpire di più è forse lâingannevole moltiplicazione suggerita dal titolo. Chissà che cosa ne avrebbe pensato il professor Nash di A Beautiful Mind.
(Articolo di Alessandro Zaccuri pubblicato su Luoghi dell’Infinito. Mensile di itinerari, arte e cultura – N. 224 anno XXII gennaio 2018)