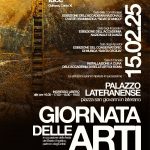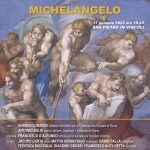Perché 800 e più milioni di uomini soffrono la fame? à la domanda che molti si fanno, ma non c’è una risposta semplice e univoca. Nei miei numerosi viaggi in paesi extra-europei ho visto quanto è difficile risolvere questa tragedia. Nel 1969 a Morato, capitale della regione dei Karimojong nel nord dell’Uganda, nella vasta area cintata dei Comboniani si erano rifugiati più di mille indigeni, seduti per terra in attesa di avere acqua e cibo. Un anno di siccità e quasi senza raccolto li aveva portati a soffrire fame e sete. I pozzi della missione davano acqua e le riserve di mais e grano permettevano di sfamarli. Centinaia di uomini, donne e bambini scheletriti e sconvolti da dolori atroci, fino a non aver quasi più aspetto di persone umane. Ho pensato a Gesù crocifisso. Tutti quei miei fratelli e sorelle, quei bambini per i quali le mamme non avevano più latte, erano crocifissi e io mi sentivo impotente, quasi colpevole. Ricordo indimenticabile, come anche in India, Bangladesh, Somalia, Namibia, Mozambico, Burkina Faso... Pregavo e mi chiedevo: perché, o Signore?
Due sono le cause del sottosviluppo africano. Innanzitutto l’arretratezza dell’agricoltura e la corruzione delle élite locali. I Paesi poveri non producono abbastanza cibo. Il senegalese Jacques Diouf, segretario della FAO, nel 2008 affermava: «Servono circa 44 miliardi di dollari l’anno per sconfiggere la fame». Ma poco prima avevo intervistato a Ouagadougou (capitale del Burkina Faso) l’arcivescovo cardinal Paul Zoungrana che diceva: «I soldi sono necessari, ma dati a un popolo che non ha la mentalità e la capacità di produrre con tecniche nuove, non creano sviluppo ma corruzione». Infatti, molti Paesi africani hanno più del 50% di analfabeti, spendono il 2% del bilancio nazionale nell’agricoltura e il 20% nelle armi. In Africa sono aumentati gli abitanti (oltre un miliardo), ma in proporzione non la produzione agricola. Europa e Stati Uniti producono troppo cibo di base e le leggi limitano la produzione, ma l’Africa nera produce troppo poco cibo. I due motori dello sviluppo sono l’agricoltura e l’educazione.
Da mezzo secolo visito le missioni, e il ritornello che spesso sento ripetere da missionari e volontari italiani presso i contadini meno istruiti è questo: «Qui si produce troppo poco per mantenere un Paese la cui popolazione aumenta rapidamente».
Il rapporto della FAO del 2001 scriveva che l’Africa nera importa circa il 30% del cibo di base che consuma (riso, grano, mais). Ecco la mia significativa esperienza: a Vercelli produciamo 80 quintali di riso all’ettaro (in Sardegna di più perché c’è più sole), nell’agricoltura africana a sud del Sahara (escluso il Sud Africa e in passato lo Zimbabwe) 5 quintali! La differenza tra 80 e 5 è l’abisso che c’è tra ricchi e poveri del mondo. E la minor produzione non è data dalla mancanza di macchine, ma dalla poca istruzione del contadino. Le campagne africane sono un cimitero di trattori che non funzionano, di pozzi da cui non si sa più tirar su l’acqua, di “progetti” fatti dall’Occidente, che i locali non hanno imparato a mantenere.
La seconda causa sta nelle tante responsabilità dell’Occidente cristiano, storiche e attuali. Lo sviluppo dell’Europa viene da Gesù Cristo e dal Vangelo che hanno cambiato il cammino dell’uomo, con il precetto dell’amore al prossimo e del perdono e tanti valori nuovi: il monoteismo, la monogamia, il concetto che rutti gli uomini sono creati a immagine di Dio e la natura a servizio dell’uomo, i Dieci Comandamenti e le Beatitudini del Vangelo, la certezza che dopo la morte ci attende il giudizio di Dio e il Paradiso… I cristiani hanno colonizzato gli altri continenti e non viceversa. La colonizzazione ha aperto i popoli al mondo moderno, ma era fatta non per favorire il loro sviluppo bensì per arricchire l’Occidente.
La radice del sottosviluppo è storico-culturale-religiosa, prima che economica e tecnica. Nel Congresso di Berlino (1884-1885) le potenze europee si spartirono l’Africa nera, le cui popolazioni (senza lingue scritte) vivevano più o meno in un’epoca preistorica. Il ritardo storico è evidente e non è possibile che popoli interi (non le loro élite) possano, in cento anni, cambiare radicalmente le loro culture e religioni e introdursi nel mondo moderno! Ecco la radicale colpa storica dell’Occidente. Luci e ombre che conosciamo. Lo schiavismo, con decine di milioni di africani portati nelle Americhe; la quasi totale assenza di un’istruzione garantita dagli Stati: in Africa le scuole (specialmente superiori) erano quelle dei missionari cattolici e protestanti. Quasi tutti i capi politici dell’Africa nera che hanno ottenuto l’indipendenza venivano dalle scuole missionarie.
 Ma ancora oggi, anche dopo l’indipendenza raggiunta negli anni Sessanta, l’Occidente continua a sfruttare quei popoli con un sistema economico ingiusto: i prezzi delle materie prime che penalizzano le risorse dei poveri; la corruzione delle classi dirigenti locali favorita dall’Occidente; la vendita di armi; il “land grabbing” ossia l’acquisto di terreni agricoli africani da parte dei Paesi ricchi per produrre cibo che viene esportato; il disboscamento delle foreste; la rapina di oro, diamanti, metalli preziosi e così via. Perché “rapina”? Perché priva l’Africa di queste ricchezze; e poi i dollari, lo sanno tutti, vengono divorati dalla corruzione delle classi dirigenti. All’inizio del 2000, la Nigeria aveva un debito estero di 92 miliardi di dollari, ma i depositi delle classi dirigenti nigeriane nelle banche occidentali era di circa 130 miliardi!
Ma ancora oggi, anche dopo l’indipendenza raggiunta negli anni Sessanta, l’Occidente continua a sfruttare quei popoli con un sistema economico ingiusto: i prezzi delle materie prime che penalizzano le risorse dei poveri; la corruzione delle classi dirigenti locali favorita dall’Occidente; la vendita di armi; il “land grabbing” ossia l’acquisto di terreni agricoli africani da parte dei Paesi ricchi per produrre cibo che viene esportato; il disboscamento delle foreste; la rapina di oro, diamanti, metalli preziosi e così via. Perché “rapina”? Perché priva l’Africa di queste ricchezze; e poi i dollari, lo sanno tutti, vengono divorati dalla corruzione delle classi dirigenti. All’inizio del 2000, la Nigeria aveva un debito estero di 92 miliardi di dollari, ma i depositi delle classi dirigenti nigeriane nelle banche occidentali era di circa 130 miliardi!
L’Occidente materialista non capisce l’Africa, perché ignora i fattori culturali, educativi, religiosi dei popoli, che danno all’uomo la sua identità , il senso di appartenenza, le motivazioni per vivere e agire. Non mi è possibile entrare nei particolari, ma chi vive e lavora in Africa (come i missionari che danno la vita per i loro popoli) ritiene che le cause storico-culturali-religiose siano fondamentali per spiegare il mancato o troppo lento sviluppo dell’Africa nera. Ma la cultura europea le ignora o le considera ininfluenti. C’è un abisso fra cosa pensiamo noi europei degli africani, delle loro culture e religioni, e le realtà dell’Africa. Quali sono le nostre responsabilità attuali verso i fratelli africani? E che cosa fare, dunque? Vorrei proporre due spunti di riflessione.
Il primo è la ferma convinzione che il maggior dono che possiamo fare all’Africa è l’annunzio di Cristo e del Vangelo. Nella Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II (1990, l’ultima enciclica missionaria) si legge (n. 59): «Lo sviluppo dell’uomo viene da Dio, dal modello di Gesù uomo-Dio e deve portare a Dio. Ecco perché tra annunzio evangelico e promozione dell’uomo c’è una stretta connessione». Alla radice del sottosviluppo ci sono mentalità , culture e religioni fondate su visioni inadeguate di Dio, dell’uomo e della donna, del creato. Santa Madre Teresa di Calcutta diceva: «La più grande disgrazia dell’India è di non conoscere Gesù Cristo».
Ancora nella Redemptoris Missio si legge: «II Vangelo è il primo contributo che la Chiesa può dare allo sviluppo dei popoli (…). à l’uomo il protagonista dello sviluppo, non il denaro o la tecnica. La Chiesa educa le coscienze rivelando ai popoli quel Dio che non conoscono (… e) il dovere di impegnarsi per lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini» (n. 58). Questa la realtà : fra i popoli arretrati i cristiani, a parità di condizioni, si sviluppano prima e meglio di altri. Il cristiano ha questo ideale: non essere egoista ma altruista, imitare Gesù Cristo e i missionari che danno la vita per i fratelli. Padre Giuseppe Fumagalli del Pime, dal 1968 nella tribù dei Felupe in Guinea-Bissau, mi diceva: «Sono i cristiani che pensano al bene pubblico e non solo della propria famiglia e tribù: parlano di pace e portano la pace, tengono aperte le strade in modo che la nostra auto-ambulanza possa andare in tutti i villaggi, combattono contro i capi-villaggio e gli anziani corrotti, danno l’esempio di famiglie monogamiche e di figli educati bene, accettano per primi le nuove tecniche dell’agricoltura».
 Il secondo punto riguarda ciò che posso fare in prima persona per aiutare i poveri. Giovanni Paolo II dice: «Contro la fame cambia la vita» (R.M. 59). Per essere fratello dei poveri, devo cambiare il mio “stile di vita”, secondo il comando di Gesù: «Il vostro superfluo datelo ai poveri» (Lc 11,41). «Chi ha più ricevuto deve dare di più» diceva l’industriale Marcella Candia, che ha venduto le sue fabbriche a Milano andando in Amazzonia a spendere la sua vita e i suoi capitali per i poveri.
Il secondo punto riguarda ciò che posso fare in prima persona per aiutare i poveri. Giovanni Paolo II dice: «Contro la fame cambia la vita» (R.M. 59). Per essere fratello dei poveri, devo cambiare il mio “stile di vita”, secondo il comando di Gesù: «Il vostro superfluo datelo ai poveri» (Lc 11,41). «Chi ha più ricevuto deve dare di più» diceva l’industriale Marcella Candia, che ha venduto le sue fabbriche a Milano andando in Amazzonia a spendere la sua vita e i suoi capitali per i poveri.
Il cristiano deve testimoniare un “modello di sviluppo” alternativo. Cambiare la convinzione che sviluppo è uguale alla continua crescita economica e alla ricerca di un benessere più opulento, quando invece è dare a tutti gli uomini il necessario alla vita. Ecco l’impegno politico del cristiano, convinto che Gesù e il suo Vangelo indicano l’ideale di un’umanità nuova secondo la volontà di Dio e che la Dottrina sociale della Chiesa traduce al meglio cosa dicono il Vangelo e la Tradizione cristiana riguardo ai problemi dell’uomo. Però non bastano soldi e macchine, leggi e giustizia internazionale, ci vogliono persone, perché lo sviluppo è un problema di educazione, di formazione delle mentalità , di evoluzione delle culture, di condivisione.
Il nostro modello attuale è materialista, volto all’avere sempre di più, al migliorare il nostro livello di vita e di consumi. Impossibile, con questo ideale, essere fratelli dei poveri. Dobbiamo allora tornare a interrogarci: noi cosa possiamo fare?
(Articolo di Piero Gheddo pubblicato su Luoghi dellâInfinito. Mensile di itinerari, arte e cultura â N. 195, maggio 2015)