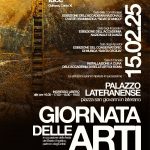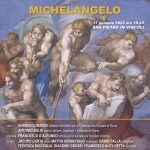Dai Buddenbrook al Gattopardo: quando la famiglia è lâanima del racconto

Un grande prato allâinglese, di un verde compatto, smaltato, nella luce del pomeriggio dâagosto. Tante sedie di paglia intrecciata, due tavolini, torte, tazzine, teiere scintillanti. E poi tovagliolini ricamati, cucchiaini e forchettine appoggiate sui piatti di porcellana decorata. E in alto, un piccolo aereo di turismo, pilotato dal figlio minore, che volteggia e si abbassa, in segno di festoso saluto.
Leggendo queste righe, chi non è subito curioso della famiglia che abita nella grande casa alla fine del prato, chi non pregusta intrecci e storie in cui entrare un poco alla volta, standosene in un angolo, come un occhio che vede e un orecchio che ascolta, vicini ma invisibili? Sono lâocchio e lâorecchio del narratore sapiente; il quale poi, a ciò che gli dicono la vista e lâudito, aggiungerà sapori e odori, quellâinesprimibile contatto con le realtà del passato che possono dare lâolfatto e il gusto, sensi primitivi e potenti, immediati.
Quel nucleo primigenio della società umana che è la famiglia ha avuto nellâOttocento e nel Novecento unâattenzione totale, avvolgente, avvolgente, da parte degli scrittori. Sono rappresentate famiglie problematiche, di solito; famiglie con segreti, in cui nulla è come appare: segreti che verranno svelati soltanto alla fine di un lungo percorso narrativo. Famiglie povere e famiglie ricche, famiglie di città e di campagna; famiglie âorizzontaliâ in cui non câè nessuna autorità , tenute insieme solo dal bisogno ossessivo di un litigare continuo, e famiglie âverticaliâ, in cui un padre-padrone o una matriarca altrettanto padrona esercitano un potere senza limiti, riducendo i familiari al silenzio sottomesso o alla spavalderia della fuga. E vengono poste di fronte ai piccoli drammi della convivenza borghese, fra ricerche di un buon matrimonio e scalate sociali, o ai grandi drammi della storia: guerre, eccidi, distruzioni, migrazioni.
Ma, anche se malata o sofferente, non se ne può prescindere. La famiglia resiste. Nessuna storia ne può fare a meno, pena la caduta nellâirrealtà o nella vaghezza. E se per caso i protagonisti sono soli, ecco che è proprio quella mancanza, la privazione di un nucleo famigliare vivo, a segnarli nella loro vitalità psichica: allora cercheranno di costruirsi una famiglia alternativa, un gruppo qualsivoglia di amici e sodali, a cui chiedere quellâintimità e quel calore infantile, fiducioso, che viene prima di ogni ragionamento o riflessione, ed è un bisogno elementare, prioritario di ogni essere umano. Intorno, poi, si irradia tutto lâarcobaleno dei personaggi minori, connessi al nucleo centrale dei protagonisti da mille legami, amicizie e inimicizie irriducibili, fraternità , crescita ed educazione, amori e disamori, vecchiaie, morti, eredità . E come cornice necessaria ci sono i paesaggi, gli sfondi che rappresentano lâanimato brulicare delle città o la vita in villa, i nuovi ricchi o i nuovi poveri, la frenetica urbanizzazione e la crescita delle metropoli o il quieto sopravvivere in campagna. Câè tutto, nella letteratura, che è lo specchio della vita: e che dà un senso alla vita.
Gli esempi sono tanti, anche a considerare soltanto le letterature occidentali: i raccontatori di storie hanno esplorato ogni piega e ogni dimensione dei rapporti famigliari, e un elenco, anche parzialissimo, è impossibile. Allora ho deciso di fermarmi a pochi esempi del Novecento, scegliendo fra i miei libri del cuore â tutti pieni di famiglie terribili, magari, ma quanto pulsanti di vita, di trame tremende, di immensi spunti narrativi!
Lessi per la prima volta I Buddenbrook in un quieto mese di agosto. Più di ogni altro mi intrigò il personaggio di Tony. Figlia e sorella dei grandi protagonisti, lei câè sempre; scorre come una farfalla sventata, facile al pianto e al racconto di sé, in tutto il libro â e lo chiude. Ogni tanto si sposa, infelicemente, poi torna alla casa avita, allâunica famiglia che riconosce, la sua, la casata dei Buddenbrook, i grandi mercanti di Lubecca. Quando il primo marito, affogato nei debiti, la accusa dia vere la smania del lusso, lei risponde: âSì, sono fatta così. à chiaro. Lâho preso dalla mammaâ. E il narratore commenta: âCon la stessa placidità avrebbe dichiarato di essere sventata, collerica, vendicativa. Il suo pronunciato senso della famiglia le rendeva quasi incomprensibili i concetti di libero arbitrio e di libertà di decisione, e le faceva constatare e ammettere le sue qualità con fatalistica indifferenza, senza distinguere e senza neppure tentare di correggersi. Senza rendersene conto, era convinta che ogni qualità , buona o cattiva, fosse un retaggio, una tradizione di famiglia, e pertanto una cosa da venerare e in ogni caso da rispettareâ.
Ho sempre pensato alla terribile malinconia di questo libro, agli eventi che accumulandosi portano alla rovina i Buddenbrook, come a un treno pieno di gente che si perde nella lontananza, senza che si conosca il punto dâarrivo, senza contatti con lâesterno, immerso nelle luci scintillanti dei vagoni che trascorrono in mezzo al buio, e nella sua folle corsa; ma anche mi è sempre parso che la cornice, la struttura in cui si muovono le famiglie dei grandi romanzi fosse come un quadro appeso al muro, che costringe dentro di sé le figurine che affollano il suo interno. Un senso di soffocamento, di aria chiusa; eppure, contemplandole muoversi come sotto una lente dâingrandimento, capita allâosservatore (al lettoreâ¦) di penetrare a fondo le dinamiche dei rapporti â dâamore e di interesse, di gelosia, di odio, di fuga â che si sviluppano in ogni famiglia; e molte volte di trarne giovamento.
Altri libri per me fondamentali, che spesso mi hanno aiutato a destreggiarmi nelle tortuose vie della vita, sono stati Il Gattopardo e Ritorno a Brideshead. Anche questi a ogni lettura offrono nuove prospettive: e mentre la storia, che già conosciamo, procede inesorabile, i personaggi si rivelano ogni volta un poco di più, e diventano nostri compagni. Certe frasi, certe riflessioni, entrano in mente come il proverbio di uno zio bislacco, o di un amico che non dimenticheremo mai. Come dimenticare la zampa possente del Principone, indifesa di fronte allâastuzia serpentina di don Calogero Sedara, nel colloquio per definire i patti nuziali di Angelica e Tancredi? Come dimenticare, anche qui, il vivido, inesorabile tramonto di un mondo, affrescato attraverso la storia di una famiglia? âNoi fummo i Gattopardi, i Leoni â riflette amaramente Fabrizio Salina, il capo della casata â ora verranno gli sciacalletti, le ieneâ. Ma la famiglia deve finire con eleganza: e nel capitolo finale, prima di diventare âpolvere lividaâ, riappare per un momento, nella carcassa del cane Bendicò che viene eliminata, lâanimale araldico che è lâinsegna della famiglia: âDurante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose per un istante: si sarebbe potuto vedere danzare nellâaria un quadrupede dai lunghi baffi, e lâanteriore destro alzato sembrava imprecareâ.
Polvere consegnata alla polvere. La contemplazione del passato sembra essere lâunico medicamento per un presente volgare e detestabile. Anche nel romanzo di Evelyn Waugh il capitano Ryder, arrivando nel 1943 col suo reggimento al castello di Brideshead, rivive il suo lungo, complicato rapporto con la famiglia di lord Marchmain, la sua amicizia per Sebastian, il suo amore per Julia. E racconta del vecchio Lord che torna dal suo lungo esilio, e in punto di morte sâincontra con Dio; e di Julia che di fronte alla conversione del padre ritrova, faticosamente, la fiammella della fede. Non câè più nessuno di loro al castello, solo un paio di vecchi domestici. Ma câè anche un vecchio prete, che tiene aperta la cappella, e dice messa. Là vanno molti soldati. E là arde indomita âuna piccola fiamma rossa â una lampada di rame battuto, di pessimo gusto, riaccesa dinanzi al cancello anchâesso di rame battuto di un tabernacolo; la piccola fiamma che gli antichi cavalieri vedevano dalle loro tombe [â¦] â. ora la fiamma ardeva di nuovo per altri soldati, lontani dalla loro casa.
(Articolo di Antonia Arslan pubblicato su Luoghi dellâInfinito. Rivista di itinerari, arte e cultura â N° 162 anno XVI maggio 2012)