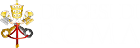Tavola rotonda al Pontificio Istituto Liturgico…
Alle ore 18,30 al Pontificio Istituto Liturgico partecipa alla tavola rotonda sul tema la riforma liturgica nella Diocesi di Roma.
Convegno sulla riforma liturgica al Sant’Anselmo
“La Riforma liturgica nella diocesi di Roma”: convegno al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (piazza Cavalieri di Malta, 5)
Gli studenti del Ripetta realizzano un mosaico per la Caritas
“Trasmettere” è il titolo del mosaico realizzato dagli studenti del Liceo artistico Ripetta per la Cittadella della Carità. L’opera è stata inaugurata oggi da monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma. L’iniziativa è stata realizzata dai giovani del quinto anno nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro attivato presso i centri della Caritas.
«Tra le tecniche artistiche consegnate dal tempo – scrivono gli studenti presentando l’opera -, quella del mosaico rappresenta al meglio due concezioni: una esecutiva, si tratta di piccole tessere quadrangolari fissate su calce e intonaco freschi, e una espressiva, data dalla figura che da quella pratica affiora. L’uno e il tutto sono, così, armoniosamente integrati: la tecnica musiva, unita allo stile che ne deriva, trasmette vita all’epifania dell’immagine. Così è anche per noi, frammenti isolati ma anche parti di un insieme. Se ci accostiamo gli uni agli altri, fino a unire le nostre mani in un intreccio, avvertiamo di far parte di un tutto. E da quell’intreccio amoroso riceviamo energia e vita».
30 maggio 2018
Il Rotary Club Eur dona un nuovo ecografo al Poliambulatorio Caritas
«La malattia è di per se una condizione emarginante e quando si presenta in persone fragili, povere, in condizioni sociali deprivate, può divenire una esperienza devastante. Ma può anche essere occasione di incontro, di relazione, di accoglienza e di cura. Per fare ciò servono persone formate e motivate, strumenti tecnici adeguati e il sostegno della Comunità. Oggi questi elementi si incontrano e testimoniano impegno e professionalità». Queste le parole pronunciate da monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, durante la cerimonia di consegna di un nuovo ecografo, donato dal Rotary Club Eur al Poliambulatorio dell’organismo cattolico che si trova nei pressi della Stazione Termini (via Marsala, 97), allo scopo di assicurare continuità di diagnosi e assistenza a quanti rimangono ai margini del Servizio Sanitario Nazionale.
La partecipazione e l’energia positiva manifestate da tutti, hanno commosso il presidente del Rotary Club Eur, Carla Lendaro, la quale ha voluto sottolineare come «l’impegno profuso dai medici volontari e dalla Caritas per la tutela della salute di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro provenienza sociale, economica o geografica, sia la più nobile affermazione del diritto alla dignità dell’essere umano».
Con il nuovo ecografo, potrà essere incrementata l’attività di diagnosi integrata con l’attività clinica di cura e prevenzione, con la possibilità di assistere tempestivamente quanti sono in condizione di marginalità e bisogno.
30 maggio 2018
Il film su Francesca Cabrini a San Tommaso Moro
Sarà proiettato venerdì 8 giugno, alle ore 18.30, nella parrocchia di San Tommaso Moro (via dei Marrucini, 1 – zona San Lorenzo) il film-documentario “Frances Xavier Cabrini: the people’s saint”, in italiano con parti in inglese sottotitolate. Seguirà un incontro monsignor Guerino Di Tora, presidente della Fondazione Migrantes, e Lucia Mauro, regista e autrice del film. Modera Umberto Mucci, fondatore di “We the italians”.
Il film ricostruisce con scene girate e interviste la vicenda della patrona degli immigrati e del personale ospedaliero, Francesca Cabrini, nata nel 1850 a Sant’Angelo Lodigiano, in Italia, e morta nel 1917 a Chicago, Illinois. «Una persona – ha dichiarato la regista – di grande umanità che aiutò i bambini, i poveri, i malati e gli immigrati adattandosi alla vita in una nuova terra. Fondò le Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, e fu la prima cittadina naturalizzata degli Stati Uniti ad essere canonizzata santa, nel 1946. La sua eredità è globale e rimane rilevante anche per i nostri tempi».
30 maggio 2018
A Ostia una veglia di preghiera aspettando il Corpus Domini
Le otto parrocchie riunite nella XXVI prefettura della diocesi si ritroveranno a pregare tutte insieme, mercoledì 30 maggio dalle ore 21, sulla spiaggetta dell’Idroscalo: la veglia è organizzata in vista del Corpus Domini, che Papa Francesco celebrerà nel quartiere del litorale domenica 3 giugno. “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi” (Gv 15, 21) è il versetto che farà da filo conduttore alla liturgia della Parola di mercoledì prossimo.
Come detto, le parrocchie di Ostia sono otto, sei delle quali appartengono alla diocesi di Roma. Si tratta di Santa Monica, Nostra Signora di Bonaria, Santa Maria Regina Pacis, Santa Maria Stella Maris, San Nicola di Bari, San Vincenzo de’ Paoli. Altre due parrocchie appartengono alla diocesi suburbicaria di Ostia, la più piccola d’Italia: Sant’Agostino Vescovo a Stagni e Sant’Aurea a Ostia Antica.
28 maggio 2018
Caritas, la Summer School per operatori di pace
Sono aperte le iscrizioni alla Summer School per operatori di pace, promossa dall’Area pace e mondialità della Caritas diocesana. C’è tempo fino al 13 giugno per presentare la domanda di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.caritasroma.it. La partecipazione è aperta a un massimo di 30 persone.
La Summer School si svolge a Roma, è itinerante e prevede incontri con esperti, laboratori interattivi e testimonianze, da lunedì 18 a martedì 19 giugno dalle ore 9 alle ore 18. «Operare per la pace richiede consapevolezza, lavoro e metodo – sottolineano gli organizzatori –. Si è operatori di pace non solo perché si prendono a cuore le cose quando l’emozione ci massacra di sensi di colpa, ma soprattutto perché si organizzano la vita, le scelte, le energie, convinti che valga la pena farlo perché ogni uomo possa vivere con dignità. Il percorso formativo non si limita all’analisi delle situazioni ma propone piste di lavoro e buone pratiche».
30 maggio 2018
Il Papa a Ostia, l’impegno delle parrocchie «in uscita»
Grande attesa per Papa Francesco che il prossimo 3 giugno alle ore 18 sarà ad Ostia per la celebrazione del Corpus Domini sulla piazza antistante la parrocchia Santa Monica, cui seguirà la processione eucaristica lungo Corso Duca di Genova con la conclusione nel parcheggio di via della Martinica, nei pressi della chiesa Nostra Signora di Bonaria. Per le parrocchie di Ostia che si preparano all’atteso appuntamento è tempo di discernimento, dopo i clamori dei media sui fatti di mafia e la riflessione diocesana sulle malattie spirituali, in un impegno «in uscita» accanto alla gente per far fronte alla crisi della fede e al disagio economico e sociale. Un tempo di verifica per una presenza rinnovata nella sostanza e nello stile, sentiti come urgenza comune. «Si sta cercando davvero di togliere le barriere tra le diverse proposte parrocchiali», spiega Angelica Alexandris Lucchi, responsabile del gruppo scout a Nostra Signora di Bonaria.
Lo conferma Marisa Licursi, a Regina Pacis nella pastorale giovanile: «Il nostro territorio ha un tesoro incredibile. Il Papa ci sta spingendo ad una sinergia ricca di futuro». Ed è la qualità delle relazioni che muove la giovane parrocchia Sant’Agostino a Stagni: «Ne è frutto l’oratorio – spiega Evelyn Franconieri, responsabile –: proposte quotidiane di sport, musica, lingue per 50 bambini e 25 adulti, condividendo le proprie capacità». Stessa dinamica a San Nicola di Bari: «Stiamo cercando di incontrare le persone, in modo nuovo», sottolinea Lorenzo Sambalino, papà di 3 bambini, del gruppo famiglie.
«Creare reti tra adulti, favorire incontro, ascolto, amicizia, in sinergia con il gruppo scout». E proprio dai limiti nascono anche nuove dinamiche: «Tanti ragazzi, terminata la catechesi per la cresima – sottolinea Fabrizio Vignato, catechista e papà di due ragazzi –, abbandonano la comunità. Questa consapevolezza ci spinge a generare una risposta». Il segreto è «fare squadra» per Marco Magistri, catechista delle Cresime, «anche nel poco tempo a disposizione».
Puntare poi ad una nuova capacità di accoglienza: «In un momento difficile della mia vita familiare – confessa Maria – ho sperimentato nella parrocchia, che frequentavo frettolosamente per le mie figlie, ascolto e attenzione. Poi l’invito alle catechesi per non credenti (promosse sul territorio dalle comunità neocatecumenali di Stella Maris, Regina Pacis e San Vincenzo De Paoli con circa 260 fratelli, ndr) che mi hanno permesso di guardare oltre». Di apertura parla anche Alessandro Bianconi, papà di 4 bambini, allenatore di calcetto a San Nicola di Bari: «Siamo scesi in campo con alcuni papà per offrire una porta di accesso alla comunità, ampia e rivolta alle famiglie più lontane. La scuola calcio – gratuita e attiva ogni sabato pomeriggio per junior e senior – accoglie ad oggi 40 ragazzi». Accoglienza mirata ancora della disabilità a Nostra Signora di Bonaria.
«A seguito dell’aumento di casi di disturbi dello spettro autistico o neuropsichiatrici», spiega Massimo Soraci, diacono. Da segnalare pure il progetto “cuore di cuoio”, laboratorio per giovani con diverse disabilità, con realizzazione e vendita di manufatti. Per tutti infine il desiderio di una visione e formazione qualificata d’insieme: apprezzatissime le iniziative promosse per gli operatori Caritas del territorio in frontiera quotidianamente nelle 8 parrocchie. Dalla distribuzione di cibi e vestiario, al servizio docce, al centro d’ascolto, allo sportello lavoro insieme al Centro per la vita, presidio di dignità per le mamme in difficoltà.
Su affettività e sessualità da segnalare i corsi con il metodo “teen star” a San Nicola di Bari, con 30 ragazzi coinvolti. E per i giovani, di «formazione senza sconti» parlano gli Scout d’Europa, ad Ostia dal 1976 con 3 gruppi ed oltre 350 ragazzi, che insieme ai 2 dell’Agesci portano l’esperienza scout a circa 500 giovani: «I ragazzi chiedono adulti credibili. Siamo chiamati a testimoniare loro con passione e alle famiglie con chiarezza la bellezza della proposta educativa, esigente per tutti – conclude Paolo Bramini, tra i responsabili – accogliendo e camminando generosamente insieme».
29 maggio 2018
di Laura Galimberti, da Romasette
Santa Bibiana dopo il restauro, convegno e benedizione
Ripulita, splendente, con tutte le dita e orientata secondo la volontà di Gian Lorenzo Bernini: si presenterà così la statua di Santa Bibiana, domani, mercoledì 30 maggio, quando verrà benedetta dal vescovo del settore Centro e segretario generale del Vicariato monsignor Gianrico Ruzza. Il presule benedirà l’opera e presiederà la celebrazione eucaristica alle 18.30, nella chiesa intitolata appunto a Santa Bibiana, in via Giovanni Giolitti, 154.
La cerimonia sarà preceduta dal convegno “Santa Bibiana dopo il restauro. La nuova visione dell’opera ricollocata secondo il progetto di Gian Lorenzo Bernini”, in programma alle 17 presso la sede della Fondazione Enpam, in piazza Vittorio Emanuele II, 78, non lontano dalla parrocchia. All’incontro interverranno Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam; Francesco Prosperetti, soprintendente della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; Geraldine Leardi, curatore storico dell’arte della Galleria Borghese; Maria Grazia Chilosi, restauratrice della Cbc, Conservazione beni culturali; Giampiero Malagnino, presidente Piazza Vittorio Aps e vicepresidente vicario Fondazione Enpam; Pietro Petraroia, storico dell’arte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Gennaro Berger, presidente Esquilino Vivo.
29 maggio 2018