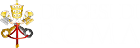Una vasta area tra Mozambico, Zimbabwe e Malawi è stata colpita dal ciclone Idai dopo settimane di piogge torrenziali e alluvioni. Nonostante le cifre ufficiali siano ancora in aggiornamento, la situazione sul posto è definita «terrificante»: oltre 200 vittime già registrate, ma le stime parlano di più di mille. Complessivamente sono più di un milione e mezzo le persone colpite, centinaia di migliaia gli sfollati, case e edifici pubblici distrutti, strade bloccate con diverse zone ancora inaccessibili. Ancora una volta i Paesi più poveri subiscono le conseguenze peggiori dell’aumento di intensità e frequenza delle catastrofi ambientali, provocate anche dai cambiamenti climatici. Papa Francesco ha espresso il suo «dolore e vicinanza alle care popolazioni del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi, colpite da ciclone Idai. Affido le molte vittime e le loro famiglie alla misericordia di Dio».
In Mozambico, informa una nota dell’Area pace e mondialità della Caritas di Roma, la zona maggiormente colpita è l’area centrale, in particolare la città costiera di Beira con il 90% degli edifici distrutti o danneggiati, ed i villaggi circostanti in tutta la provincia di Sofola. Danneggiato gravemente anche parte dell’ospedale e le più importanti strade di accesso alla città. Il porto è funzionate solo in parte, ma questo consente l’arrivo degli aiuti via mare. Colpite da alluvioni anche altre provincie centrali di Manica, Zambezia e Tete, nonché parte di quella settentrionale di Niassa. Molti dei villaggi più interni sono rimasti isolati e ancora inaccessibili ai soccorsi.
In Zimbabwe ci sono almeno un centinaio di morti e oltre 200 dispersi. Anche qui i danni alle abitazioni e alle infrastrutture sono gravi. Le prime stime parlano di oltre 900 edifici distrutti. La regione di Chimanimani è tra le più colpite, molte zone sono inaccessibili anche agli elicotteri rendendo i soccorsi molto difficoltosi.
Anche nel Malawi centrale e meridionale, il ciclone e le alluvioni hanno provocato danni ingenti con decine di morti, più di 500 feriti e oltre 140.000 sfollati in 13 distretti. Maggiormente colpiti le aree di Chikwawa, Zomba, Balaka, Machinga, Dedza and Ntcheu.
Nonostante le difficoltà, le Caritas dei tre paesi si sono prontamente mobilitate attraverso gli organismi nazionali, diocesani e le parrocchie nell’assistenza agli sfollati e nella raccolta di informazione per la predisposizione di un primo piano organico di intervento d’urgenza. In particolare in Mozambico i volontari mobilitati dalla Caritas sono impegnati nella distribuzione di beni di prima necessità e nella prevenzione delle epidemie con campagne di informazione igienico sanitarie, lo scavo di canali per il deflusso delle acque e la creazione di punti di raccolta di rifiuti presso i centri di accoglienza che ospitano gli sfollati. In tutti i paesi i bisogni più urgenti per gli sfollati sono ripari d’urgenza, beni non alimentari di prima necessità (coperte, utensili per la cucina ecc.), cibo, acqua potabile, kit igienico sanitari.
La rete internazionale della Caritas è attiva per supportare le Chiese locali nella fase di emergenza.
Per contribuire:
Conto corrente postale
Numero: 001021945793
intestato a Fondazione “Caritas Roma” – ONLUS
Via Casilina Vecchia 19 – 00182 Roma
Causale: Alluvioni Africa 2019
Bonifico Bancario
Banco Posta IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793
Causale: Alluvioni Africa 2019
26 marzo 2019