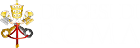- This event has passed.
San Giovanni di Dio (1495-1550)
18 Maggio 2020 @ 0:00
Event Navigation
San Giovanni di Dio
Giovanni Cidade Duarte nacque dunque nel 1495 a Montemoro-novo (Montemaggiore Nuovo, un villaggio dal nome promettente). Di Giovanni bambino non sappiamo quasi nulla, finché all’età di otto anni non gli accade di incontrare un pellegrino: un viandante entrato nella sua casa a chiedere alloggio e intrattenere gli ospiti col racconto dei suoi viaggi. Che cosa sia poi avvenuto non è possibile dire, ma la mattina dopo i genitori s’accorgono che il pellegrino ha ripreso la strada e che il bambino è fuggito con lui: fuggito o forse rapito. Chissà! Certo è che essi non riescono più a rintracciarlo, e la mamma, stroncata dall’angoscia, non sopravvive più di venti giorni a tanta sventura. Il papà, invece, finisce i suoi anni in un convento di francescani. Il piccolo Giovanni compì così un lungo viaggio a piedi, fino a Madrid, assieme a mendicanti, saltimbanchi e giocolieri, imparandone la strana professione. Giunti vicino a Toledo, il viandante abbandonò il fanciullo, probabilmente sfinito, nelle mani di un buon uomo del posto, Francisco Majoral, intendente delle greggi del Conte di Oropesa, un signore di cui si conoscono le virtù e la carità.
Per sei anni Giovanni viene educato come un figlio: poi, dai quattordici ai ventott’anni, vive come un pastore, nella solitudine dei monti e nella contemplazione della natura, seguendo le greggi.
Ma quando infine sembra che egli possa sistemarsi definitivamente sposando la figlia del Majoral, con la quale è vissuto fraternamente fin dall’infanzia, Giovanni fugge ancora.
Giovanni Cidade vuole libertà: “Quella libertà, scrive il suo biografo, che sogliono avere quelli che seguono la guerra, correndo a briglie sciolte la via ampia (seppur faticosa) dei vizi”. Siamo nell’epoca in cui, dopo il cavaliere medievale, sta nascendo la figura del “soldato”. Ma al nostro avventuriero la vita militare riserva solo disgrazie. Una volta il cavallo in corsa, imbizzarrito, lo disarciona gettandolo contro le rocce che fiancheggiano il sentiero, e Giovanni rimane a lungo privo di conoscenza, come morto.
Un’altra volta, messo a guardia di un bottino di guerra, si lascia imprudentemente derubare: viene degradato e condannato a morte; ma viene graziato per l’intervento pietoso d’un personaggio ragguardevole.
Ambedue furono esperienze fisiche di morte e di grazia, che si depositarono nel profondo della sua coscienza. Tornò dal Majoral, suo antico padrone, dopo un interminabile viaggio a piedi di circa seicento chilometri, come un fallito, riprendendo a fare di malavoglia il pastore.
Passarono altri due anni. Nel 1527 sente dire che il sultano dei Turchi, Solimano Il, è entrato in Ungheria e ha posto l’assedio a Vienna. Gli rinasce il desiderio della lotta. Dopo alcuni mesi le truppe intrapresero il viaggio di ritorno, ripercorrendo la stessa strada, ma la compagnia di Giovanni Cidade ebbe invece l’ordine di attraversare la Germania, toccare le Fiandre e noleggiare una nave per la Spagna.
Sbarcarono al porto di La Coruna, non lontano da Santiago di Compostela, e tutti vi si recarono in pellegrinaggio. Poi la compagnia si sciolse. Solo ora, imprevedibilmente, Giovanni pensa di tornare al paese natio che ha abbandonato da bambino: percorre a piedi i seicento aspri chilometri che lo separano da Montemoro-novo. Cerca la casa dei suoi genitori, sperando di trovarli ancora in vita.
Quando scopre quel che è loro accaduto, lo assale un dolore atroce e uno sconvolgente senso di colpa. Si sente responsabile della loro morte: “Sono tanto cattivo e colpevole, si dice, che devo occupare la mia vita, dono del Signore, a fare penitenza e a servirlo”. Si reca allora a Siviglia dove commercia in bestiame: di fatto fa ancora il pastore per una ricca signora del luogo. Ma dura soltanto alcuni mesi. E inquieto.
Si reca a Gibilterra e pensa di arruolarsi nella spedizione che Carlo V prepara contro Tunisi.
A Ceuta si mette a servizio di un nobile decaduto, ma finisce per prendersi cura della famiglia ridotta in miseria, mantenendola col suo lavoro. La carità gli allarga il cuore: cerca un padre spirituale che gli raccomanda la lettura del Vangelo e di libri spirituali.
Torna in Spagna e si immerge per ore intere nella lettura di testi di spiritualità: spende tutti i suoi risparmi per acquistare libri per sé e per gli altri e si mette a percorrere i villaggi vendendo libri ai dotti, e immagini agli incolti e ai fanciulli. Ma, prima di venderli, legge tutto quel che può: poi mette i libri alla moda in bella mostra, ma quando i giovani si avvicinano per acquistarli, li sconsiglia e li convince a comprare quelli spirituali. Giunge addirittura a metter su una bottega di libri. Che Giovanni abbia imparato, lui per primo, è evidente: ci restano di lui sei lunghe lettere che contengono numerosissime citazioni della Bibbia e dell’Imitazione di Cristo. A quarantatré anni egli può vivere dunque agiatamente nella sua botteguccia di Granada.
Ma Dio lo attende in quel gennaio del 1539, alla festa di San Sebastiano, quando giunse in città uno dei più celebri predicatori del tempo: Giovanni d’Avila, l’apostolo dell’Andalusia. Giovanni è tra gli ascoltatori e si sente dire che ognuno deve “ancorarsi nella volontà di soffrire e perfino di morire piuttosto che commettere il peccato, che è il flagello più pericoloso”. Tutti comprendono il riferimento, perché la regione è devastata dal flagello della peste. A quel paragone, il nostro “venditore di libri” è colto da un moto irrefrenabile di pentimento: gli passano davanti agli occhi le immagini di tutta la sua vita disordinata, e i peccati commessi fin dagli anni della gioventù. Di mezzo agli ascoltatori, egli si mette a gridare: “Misericordia, mio Dio, misericordia!”. Sembra diventato pazzo: si getta a terra, batte la testa contro i muri, si strappa la barba. Corre verso la sua bottega inseguito da una folla di bambini che gli urlano dietro: “Pazzo! Pazzo!”.
Dà il suo denaro a chi lo vuole, distribuisce libri sacri e oggetti di pietà, strappa con le mani e con i denti le opere profane, si priva perfino delle sue vesti. Corre da Giovanni d’Avila e fa una lunga confessione, poi si reca in piazza dove c’è un grande pantano e ci si rotola dentro e comincia a confessare pubblicamente i suoi peccati. I ragazzi gli gettano addosso altro fango ed egli se ne va tutto felice, con una croce in mano, che dà da baciare a chiunque incontra.
Alcuni biografi spiegano che ha fatto tutto questo perché vuole sembrare pazzo “per amore di Cristo”.
Altri sostengono invece che si trattò di un vero e proprio attacco di follia: troppe esperienze, troppe tensioni, troppa tenebra e troppa luce, troppa durezza e troppa tenerezza, e soprattutto troppo bisogno d’amare e troppa mancanza d’oggetti reali degni d’amore.
Di fatto finì in un manicomio: uno di quelli di allora dove la cura consisteva nell’incatenare i malati più inquieti, per poi calmarli a furia di nerbate. Ma questo malato era strano, perfino nella sua pazzia.
Quando egli stesso veniva frustato, incitava gli “infermieri” a continuare “perché era giusto che pagasse quella carne con cui egli aveva peccato”. Ma se frustavano qualche altro poveretto, allora inveiva contro gli “infermieri”: “Traditori, perché trattate tanto male e con tanta crudeltà questi poveri infelici, miei fratelli, che si trovano in questa casa di Dio e in mia compagnia? Non sarebbe meglio aver compassione delle loro prove, tenerli puliti e dar loro da mangiare con maggiore carità e affetto di quanto fate?”. E rinfacciava loro lo stipendio che ricevevano per curare i malati e non per maltrattarli. Il risultato era che lui prendeva doppia razione di frustate. Ma Giovanni diceva: “Che Gesù Cristo mi accordi la grazia di possedere un giorno un ospedale dove io possa accogliere i poveri abbandonati e gli infelici privi di ragione, per servirli come desidero”. Dopo qualche giorno si presentò al direttore del manicomio e gli disse: “Benedetto sia il Signore, io mi sento in buona salute e libero da ogni angoscia”. Per darne prova, chiese di poter servire gli altri malati e dimostrò una serenità e una carità stupefacenti.
Aveva ormai quarantaquattro anni e gliene restavano da vivere soltanto undici. Ma in così breve tempo egli divenne “il Padre dei poveri”, il “patriarca della carità”, “la meraviglia di Granada”, “l’onore del suo secolo”: tutti titoli che gli furono attribuiti.
Cominciò a lavorare raccogliendo e rivendendo legna, finché poté acquistare una casupola davanti al mercato del pesce, nella quale raccolse i primi derelitti.
Al mercato si faceva regalare i pesci invenduti, dato che allora era impossibile conservarli, e li cucinava per i suoi malati, tanto che divenne esperto nel preparare un’ottima zuppa di pesce.
Ogni sera poi percorreva i quartieri alti recando una gerla sul dorso e due marmitte ai lati sospese a una corda passata sulle spalle e percorreva così le strade gridando:
“Qualcuno vuol fare del bene a se stesso? Fratelli miei, per amor di Dio, fate bene a voi stessi!”.
È questo il significato originario del motto che oggi dà il nome al suo Ordine religioso: “Fatebenefratelli!”. L’espressione non voleva dire in primo luogo che bisogna prendersi cura dei fratelli più poveri, ma che bisogna “farsi del bene”, facendo del bene al prossimo.
Non si riesce ad amare veramente i poveri se prima non si scopre la propria incredibile povertà, il dovere di arricchire la propria misera vita, facendo del bene a se stessi col fare il bene agli altri.
Cominciarono le prime donazioni e la casa poté ingrandirsi. Giovanni prese a ricoverare i suoi malati selezionandoli e distribuendoli secondo la malattia: una stanza per i febbricitanti, una per i feriti, una per gli invalidi; il pianterreno era invece riservato ai viandanti e ai mendicanti che non trovavano un tetto dove ripararsi. Tutto questo in un tempo in cui negli ospedali i malati venivano ammucchiati senza distinzioni, mettendo più infermi nello stesso letto.
Si curava personalmente di tutto: accoglieva i bisognosi, li lavava, procurava il cibo, lo cucinava, rigovernava, spazzava i pavimenti, lavava la biancheria, andava per acqua e per legna.
E i visitatori restavano impressionati dell’ordine e della pulizia.
Se all’inizio dell’opera ancora lo consideravano pazzo, ora lo chiamavano: “il Santo”.
Aumentano le offerte, i crediti; alcuni si dicono disposti ad aiutarlo e a condividere la sua fatica; gli stessi poveri più validi diventano infermieri.
Un alto prelato di Granada si diede a proteggerlo; un giorno, però, gli impose di abbandonare le sue vesti cenciose e di indossare una tunica sobria ma pulita. Poi gli diede un nome: “Ti chiamerai Giovanni di Dio”, gli disse. “Oh sì, rispose Giovanni, se piace a Dio!”.
Il suo scopo era sempre chiarissimo. Diceva: “Attraverso i corpi, alle anime!”.
Per questo chiamava al suo ospedale i più zelanti sacerdoti a collaborare con lui.
Una sera d’inverno rientrava tenendo con una mano la cesta piena di viveri, appoggiandosi con l’altra a un bastone e portando sulla schiena un povero ammalato trovato sulla pubblica via.
La strada saliva faticosamente, e veniva giù un terribile acquazzone.
Giovanni scivolò e cadde. Alle grida del malato qualcuno s’affacciò alla finestra e vide Giovanni che si picchiava col bastone sulle spalle gridando a se stesso:
“Signor asino, stupido, fiacco, pigro, non hai forse mangiato oggi? Allora perché non lavori? I poveri ti attendono e guarda che cosa hai combinato a questo moribondo!”.
Poi si riaccomodò il malato sulle spalle e afferrò nuovamente la cesta, trascinandosi fino all’ospedale.
Quando a Granada il grande ospedale regio fu distrutto da un incendio, Giovanni si gettò nel fuoco per salvare i malati. L’antico Breviario, nel giorno della sua festa, commentava così l’episodio: “Insegnando la carità, mostrò che il fuoco esterno aveva su di lui minor forza del fuoco che lo bruciava interiormente”.
E fu questa la scena che venne raffigurata nella Gloria del Bernini il giorno della canonizzazione.
Intanto il suo ospedale cresceva.
Scrive Giovanni in una lettera: “Sono tanti i poveri che qui giungono, che io stesso, molte volte non so come si possano alimentare, ma Gesù Cristo provvede a tutto e dà loro da mangiare, perché solo per la legna occorrono sette o otto reali ogni giorno; perché essendo la città grande e molto fredda, specialmente adesso d’inverno, son molti i poveri che giungono a questa casa di Dio; perché tra tutti, infermi e sani e gente di servizio e pellegrini ce ne sono più di cento e dieci… Vi sono rattrappiti, mutilati, lebbrosi, muti, pazzi, paralitici, tignosi, e molti vecchi e molti bambini; e senza contar questi, molti altri pellegrini e viandanti che giungono e si dà loro fuoco e acqua e sale e recipienti per cucinare e mangiare, e per tutto questo non c è rendita; ma Gesù Cristo provvede a tutto…
E in questo modo sono indebitato e prigioniero solo per Gesù Cristo…”.
All’inizio del 1550 si ammalò gravemente; una sua nobile benefattrice lo trovò febbricitante sul suo povero letto, fatto di una nuda tavola, mentre il cesto della questua gli serviva da cuscino.
Ottenne dall’Arcivescovo il permesso, un ordine per Giovanni, di portarlo nel suo palazzo nobiliare. Mentre lo conducevano via, i poveri gridavano e protestavano accerchiando la portantina e Giovanni era sconvolto. Li benediceva piangendo e diceva: “Dio lo sa, fratelli miei, se desidererei morire in mezzo a voi! Ma poiché Egli vuole che io muoia senza vedervi, sia fatta la sua volontà!”.
Nel letto troppo soffice Giovanni rivelò all’Arcivescovo che era angustiato da tre cose:
“La prima: aver servito così poco Nostro Signore, mentre ho ricevuto tanto.
La seconda: i bisognosi, le persone uscite dal peccato e i poveri ritrosi che ho preso a mio carico.
La terza: questi debiti che ho contratto per Gesù Cristo”. E, così dicendo, gli mise tra le mani il registro dei debiti che portava stretto sul cuore. Non ebbe pace finché l’Arcivescovo non si impegnò personalmente a soddisfarli. Alla prima alba dell’8 marzo, quando ancora non c’era nessuno attorno al suo letto, discese da quel giaciglio troppo comodo, si inginocchiò per terra stringendo al petto il suo Crocifisso e spirò all’età di cinquantacinque anni. Lo trovarono così, già morto da tempo, ma ancora in ginocchio. Le esequie furono imponenti: la bara era portata da quattro gentiluomini della più alta nobiltà, ma al primo posto nel corteo venivano i poveri del suo ospedale.
“Amò tanto la povertà che, se avesse incontrato insieme un angelo e un povero, avrebbe lasciato l’angelo e abbracciato il povero”. “A Betlemme ti amò Dio-bambino nella culla, e all’ospedale Dio-infermo nel letto”.
Preghiera
Ai vostri piedi prostrato,
o gran padre degli infermi,
vengo oggi per impetrare da voi
che siete dispensatore di celesti tesori,
la grazia della cristiana rassegnazione,
e la guarigione dei mali che travagliano
il corpo e l’anima mia.
O medico celeste,
deh! non sdegnate di venire in mio soccorso,
ricordandovi i prodigi di carità
operati nei giorni della vostra mortale carriera
a beneficio dell’umanità sofferente.
Siate voi il balsamo salutare
che lenisca i dolori del corpo:
voi il freno potente che trattenga l’anima
da fatali traviamenti:
voi il conforto, la luce, la guida
nell’aspro sentiero che porta alla salute eterna.